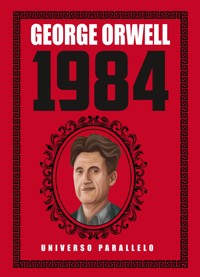
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Youcanprint
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Englisch
«Mentre nel libro di Huxley si parla veramente di un altro mondo, di un'altra civiltà, in 1984 è il nostro mondo che agonizza davanti a noi. » 1984 (Nineteen Eighty-Four) è uno dei più celebri romanzi di George Orwell, pubblicato nel 1949 ma iniziato a scrivere nel 1948 (anno da cui deriva il titolo, ottenuto appunto dall'inversione delle ultime due cifre). Le Monde lo posiziona al 22º posto della classifica dei 100 migliori libri mai scritti. La specificità del romanzo 1984 (Nineteen Eighty-Four): "Nella comprensione profonda delle possibilità di manipolazione psicologica dello stato totalitario, va individuata la vera specificità di 1984, il romanzo più famoso di Orwell. Nell'incubo fantascientifico lì descritto, l'autorità dell'Oceania è programmaticamente orientata ad imporre un linguaggio inadatto all'espressione delle potenzialità critiche del pensiero. Cerca quindi di abituare le menti umane alla tolleranza (diciamo sudditanza) per le contraddizioni logiche che caratterizzano la propaganda politica del Grande Fratello, e cerca di canalizzare l'emotività individuale nelle sole direzioni utilizzabili per la riproduzione dell'ordine sociale. Orwell ha presentato in modo così accurato processi mentali ("bipensiero") e strutture linguistiche ("neolingua") funzionali all'irrazionalismo sociale totalitario, che 1984 è diventato una citazione d'obbligo nei manuali di psicologia sociale e negli studi sulla comunicazione interpersonale"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
GEORGE ORWELL
1984
(1984, 1949)
Da Universo Parallelo
George Orwell
La vita
Eric Arthur Blair, vero nome di George Orwell, nasce il 25 giugno 1903
a Motihari, nel Bengala, dove il padre, d'origine angloindiana, è funziona-rio statale presso l'Opium Department. La sua famiglia appartiene alla borghesia «alto-bassa», come la definirà lo stesso scrittore con sarcastica con-traddizione. Al ruolo dominante e privilegiato degli amministratori britan-nici nelle colonie non corrisponde, infatti, un analogo status in Inghilterra.
In India, i Blair si destreggiano a conciliare effettiva scarsità di mezzi e salvaguardia delle apparenze quando, nel 1904, Eric torna in patria con la madre e le due sorelle e si stabilisce a Henley-on-Thames. Iscritto nell'e-sclusivo college St. Cyprian di Eastbourne, ne esce con una borsa di studio e un opprimente complesso d'inferiorità, come racconta nel saggio auto-biografico E tali, tali erano le gioie del 1947. Né riuscirà a integrarsi nel clima altrettanto snob, seppur meno gretto, di Eton, dove è ammesso nel 1917.
Il senso di sradicamento è probabilmente alla base della sua decisione di seguire le orme paterne arruolandosi nel 1922 nella Polizia imperiale indiana a Mandalay, in Birmania. Pur se ispirerà il suo primo romanzo (in ordine di composizione, ma edito solo nel '34), Giorni in Birmania, l'esperienza si rivela traumatica. Diviso fra il crescente disgusto per l'arroganza imperialista e la funzione repressiva che il suo ruolo gli impone, Eric si dimette nel 1928. Nello stesso anno parte per Parigi. Il suo non è solo un pellegrinaggio nella capitale intellettuale, ma una vera e propria esplora-zione dei bassifondi, dove sopravvive grazie alla carità dell'Esercito della Salvezza, sobbarcandosi lavori umilissimi. Un'avventura che continuerà subito dopo anche in patria e accenderà estro al romanzo d'esordio, Senzaun soldo a Parigi e a Londra, pubblicato nel '33 con il nome di George Orwell.
Tra il 1932 e il 1936 alterna alle fatiche di romanziere quelle di in-segnante e di commesso di libreria, che entreranno nelle descrizioni d'am-
biente dei due romanzi successivi, La figlia del reverendo del '35 e Fioriràl'aspidistra del '36. Su commissione del Left Book Club, un'associazione culturale filosocialista, svolge un'indagine nelle zone più colpite dalla de-pressione economica, che lo porterà, nei primi mesi del '36 tra i minatori dell'Inghilterra settentrionale. Le loro misere condizioni saranno descritte in La strada di Wigan Pier (pubblicato nel '37). Sempre nel '36 sposa in giugno Eileen O'Shaughnessy, impiegata al ministero dell'Informazione, e parte in dicembre come volontario per la guerra di Spagna, raccontata nel diario-reportage edito nel '38, Omaggio alla Catalogna.
A Barcellona si arruola nelle file del Poum (Partito operaio d'uni-ficazione marxista, d'ispirazione trotzkista) ed è inviato sul fronte aragone-se. Colpito alla gola da un cecchino franchista rientra a Barcellona. Ma il clima politico è mutato. Con il prevalere della linea del Fronte Popolare e del partito comunista nel governo repubblicano il Poum e gli anarchici so-no dichiarati fuorilegge e Orwell deve lasciare la Spagna quasi clandestinamente. Del '39 è il romanzo Una boccata d'aria.
Respinto come inabile allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola nel '40 nelle milizie territoriali della Home Guard. Gli anni dal '41 al
'46 lo trovano a Londra dove collabora a giornali e riviste («Partisan Re-view», «New Statesman and Nation», «Poetry London»), cura per la Bbc una serie di trasmissioni propagandistiche dirette all'India, è direttore letterario del settimanale socialista «Tribune», che gli affida una rubrica ( As Iplease, A modo mio).
Nel '45, anno in cui muore la moglie, è in Francia, Germania, Austria come corrispondente dell'«Observer». Sempre nel '45 appare il romanzo del successo, La fattoria degli animali.
A metà aprile del '46, sospesa per sei mesi la collaborazione con i giornali, dà inizio alla stesura del libro che diventerà 1984.
Nel '47 si stabilisce con il figlio Richard, adottato nel '44, a Jura, una fredda e disagiata isola delle Ebridi. È minato dalla tisi, il clima non si confà alle sue ormai disperate condizioni di salute, costringendolo a continui ricoveri in sanatorio. Nel '49, risposatosi con Sonia Bronwell, redattri-ce di «Horizon», si dedica, letteralmente incalzato dalla morte, alla revisione di 1984. Si spegnerà a Londra il 21 gennaio 1950.
Le opere
Secondo la puntuale corrispondenza tra esperienze esistenziali e let-
terarie che contraddistingue l'intera opera di Orwell, gli anni birmani pro-muovono i racconti di ricordi giovanili: Un'impiccagione (1931), contro la pena di morte, e L'uccisione dell'elefante (1936), confessione dei sentimenti ambivalenti — di odio per i dominatori, di simpatia per il paese op-presso ma anche d'esasperazione verso la popolazione ovviamente ostile
— che compaiono anche nel primo lavoro di ampio respiro. Giorni in Birmania (1934) s'impernia sul rifiuto dell'ipocrisia imperialista da parte d'u-no stesso sahib della comunità bianca. Pur accodandosi alla tradizione na-turalistica, il romanzo introduce in modo peculiare il motivo orwelliano dell'individuo in lotta contro il suo ambiente e destinato alla sconfitta. Che questo dissidio abbia per Orwell radici biografiche nell'insoddisfazione per i falsi valori della sua classe si conferma nella ricerca di un'umanità autentica — identificata con il sottoproletariato più emarginato e disperato —
che caratterizza i vagabondaggi narrati in Senza un soldo a Parigi e a Londra (1933). In La figlia del reverendo (1935) il tema della perdita della fe-de, vista nel duplice aspetto consolatorio e mistificatorio, approfondisce un'altra costante dei personaggi orwelliani, tentati dal rifiuto della morale piccolo-borghese ma soggetti al fascino della decency, rassicurante patri-monio di rispettabilità e dignità della loro classe. La stessa attrazione-repulsione lacera il protagonista che si declassa volontariamente in opposizione al mito del denaro in Fiorirà l'aspidistra (1936). La strada di WiganPier (1937) è la seconda tappa di quell'«accostamento al socialismo», volto a esplorare, dopo il sottoproletariato, il proletariato. Se la descrizione dei minatori soffre eccessi apologetici, il libro è illuminante per capire la natura idealistica del socialismo di Orwell. Omaggio alla Catalogna (1938), oltre che un diario di trincea, è la storia d'una rivoluzione tradita, sacrificata alle direttive della politica staliniana. Da allora in poi, come dirà nel saggio Perché scrivo (1946), ogni riga di Orwell sarà spesa contro il totalitarismo, quello che era andato a combattere e quello inaspettato che aveva incontrato. Soprattutto egli vuole smascherare la campagna di menzogne scatenata dai comunisti attraverso i mezzi d'informazione contro le altre forze della sinistra. In Una boccata d'aria (1939) il cliché dell'eroe-antieroe è proiettato contro gli effetti disumanizzanti del «progresso»: solo alla conservazione della memoria, al senso di continuità con il passato vengono attribuiti valori d'antidoto all'alienazione incombente. La sterminata produzione saggistica spazia da temi letterali come in Charles Dickens (1940) o Nel ventre della balena (1940) ad argomenti sociologici come nel Leone e l'unicorno (1941) o Gli inglesi (1944); esamina la fun-
zione sociale dello scrittore e i pericoli dell'«invasione della letteratura da parte della politica» in Letteratura e totalitarismo (1941), La prevenzionedella letteratura (1944), Gli scrittori e il leviatano (1948); dal '40 in poi manifesta un crescente interesse per i rischi d'un uso banalizzato e ideologico del linguaggio in Nuove parole (1940), Propaganda e linguaggio popolare (1944), La politica e la lingua inglese (1946). Nel saggio ArthurKoestler (1944), l'esame dell'autore di Buio a Mezzanotte e del suo romanzo incentrato sulle «purghe» del 1936 anticipa, portando l'attacco al cuore della politica stalinista, La fattoria degli animali (1945). Rimasto un uni-cum nella narrativa orwelliana, il romanzo coniuga il genere letterario della favola animale alla Esopo e La Fontaine con la lezione satirica di Swift, un maestro ben conosciuto, come dimostra il saggio Politica contro letteratura (1946).
1984 (1948) è senz'altro il più famoso esemplare del filone ispirato dalle spettrali inquietudini che le due guerre e l'olocausto atomico avevano evo-cato. Le antiche utopie positive di Bacone, More, Campanella sono ora ri-proposte in negativo: è la parabola apocalittica delle grandi paure orwel-liane — il totalitarismo, la falsificazione e la perdita di memoria storica indotta dai mezzi d'informazione, la corruzione del linguaggio, l'annulla-mento dell'identità individuale — convogliate in una raggelante descrizione di società del futuro contro cui combatte, ancora una volta, l'ultimo eroe.
La fortuna
In Orwell le continue sovrapposizioni uomo-scrittore pongono non pochi problemi interpretativi. I personaggi dei primi romanzi, in particolare, soffrendo di un eccessivo ricalco biografico, paiono mancare di efficace carat-terizzazione e, più che di vita autonoma, vivrebbero come portatori delle istanze del loro autore su particolari problemi. In questo senso proprio i romanzi premiati dal successo di pubblico, La fattoria degli animali e 1984, sono considerati, per motivi diversi, i più riusciti anche dalla critica.
Ma la scarsa attenzione prestata alle prime opere di Orwell derivò anche dalle difficoltà di pubblicazione. Giorni in Birmania uscì con anni di ritar-do per tema della censura statale; Omaggio alla Catalogna faticò non poco a trovare un editore disposto a rischiare su un'interpretazione tanto poco al-lineata della guerra civile. La stessa Fattoria degli animali, strepitoso best-seller da 11 milioni di copie, finito nel '44, capitava male — proprio quan-
do l'Inghilterra aveva più bisogno del potente alleato sovietico — e dovette aspettare un anno la pubblicazione. In Russia, poi, solo con la glasnost è stato tolto dall'indice dei libri proibiti. Vicissitudini editoriali che confer-mano a Orwell la fama di autore "scomodo". L'ansia per la verità, l'impar-zialità di giudizio perseguita quasi fino alla maniacalità, l'onestà intellettuale — che trovano l'espressione più viva in Omaggio alla Catalogna, libro rivalutato dalla moderna critica storiografica e considerato uno dei più lucidi sull'argomento — danno quasi costantemente un carattere di denuncia alla sua opera.
L'inesauribile verve polemica che nei saggi e negli articoli fece di Orwell un implacabile e magistrale pamphleter, gli costarono, letterariamente e politicamente, l'isolamento. Dall 'intellighenzia degli anni '30, dagli Au-den e dagli Spender con cui pure aveva condiviso l'esperienza spagnola, lo separa il suo irrinunciabile spirito critico nei confronti del marxismo. Gli strali immancabilmente rivolti contro una letteratura asservita all'ortodossia investono un'intera generazione d'intellettuali engagées, di «poetini ef-feminati» corrotti dallo spirito gregario e irretiti nel culto della Russia. La sua denuncia degli opposti totalitarismi lo vide inviso alla destra e alla sinistra e spesso strumentalizzato da entrambe. L'insistenza con cui dal '36
in poi si volse contro il regime comunista tende a far dimenticare che Orwell si definì sempre socialista. Certo, il suo socialismo, così come egli lo andava assestando sui cardini di «giustizia» e «libertà» non poteva identi-ficarsi con il socialismo reale. La sua società ideale, più che alla dottrina del materialismo storico, sembra ispirarsi a un primato morale, che contempla decoro, rispetto della dignità umana, tolleranza, un concetto ampio di decency, insomma, esteso a tutte le classi. Un modello sulle cui effettive possibilità di realizzazione il pessimismo di 1984 viene a porre una grave ipoteca. L'universo catastrofico di Orwell non è, infatti, che il precipitato di tutte quelle tendenze negative che egli vede già nel suo tempo. Secondo il tratto distintivo della letteratura antiutopica, per lo scrittore il futuro è già presente, nel momento in cui egli scrive il processo di degenerazione è già avviato, la massificazione ha già iniziato a corrodere il destino individuale e sociale. L'urgenza dell'avvertimento è drammatizzata in Orwell dalla vicinanza della proiezione: non un futuro remoto del prossimo mil-lennio — dove, invece, s'ambientano gli altri campioni dell'escatologia negativa del '900, Il mondo nuovo di Huxley e Noi di Zamjatin — ma addirittura un anno del suo stesso secolo, ottenuto semplicemente invertendo le cifre finali della data di composizione, 1948, del romanzo. Quindi una let-
tura che insista sull'aspetto «profetico» di 1984 — inevitabile apogeo delle monumentali celebrazioni che sono state promosse dai media allo scoccare della data orwelliana — rischia d'essere sviante. La valutazione di 1984
sulla base dell'effettiva esistenza di stati totalitari, d'uno strapotere dei mezzi di comunicazione, d'una tecnologia alienante — o di quant'altro si è voluto identificare come la maggiore intuizione orwelliana — non dovrebbe oscurarne il carattere di monito, valido per ogni futuro.
Bibliografia
Prima edizione:
Nineteen Eighty-Four, Londra 1949.
Saggi su 1984 accessibili in italiano:
E. Cecchi, Il «1984» di G. Orwell, in Scrittori Inglesi e Americani, vol.
II, Milano 1964.
A. Deidda, «1984». «Before we forget», in R. Bertinetti, A. Deidda, M.
Domenichelli, L'infondazione di Babele. L'Antiutopia, Milano 1983. S.
Manferlotti, Pozzo di Babele. Parola e morte in «1984», in «Belfagor», XXXIX, Firenze 1984, pp. 397-408. J.R. Sneyder, «1984»: antiutopia,linguaggio, storia, in «Alfabeta», 57, 1984.
F. Marroni — C. Pagetti — O. Palusci (a cura di), George Orwell
«1984». Un romanzo del nostro tempo, Pescara 1986.
L. Russo (a cura di), Orwell: «1984», Palermo 1986.
G. Bulla, Il muro di vetro. «Nineteen Eighty-Four» e l'ultimo Orwell, Roma 1989.
Inoltre: l'introduzione George Orwell di A. Chiaruttini a 1984, Milano 1973; l'introduzione Orwell o dell'energia visionaria di U. Eco a 1984, Milano 1984.
Saggi su George Orwell accessibili in italiano:
M.L. Astaldi, George Orwell critico e saggista, in «Ulisse», giugno 1950. G. Pampaloni, Ritratto sentimentale di George Orwell, in «Il Pon-te», VII, maggio 1951.
A. Garosci, George Orwell, in Gli intellettuali e la guerra di Spagna, Torino 1959.
E. Cecchi, La fattoria degli animali e Conversazioni con G. Orwell, in Scrittori Inglesi e Americani, vol. II, Milano 1964.
J. Gross, Questo è George Orwell, in «La Fiera Letteraria», 24 ottobre
1968.
J. Gross, Antiquato sì, ma fedele alle mie idee, in «La Fiera Letteraria», 31 ottobre 1968.
R. Runcini, George Orwell o l'inutile dilemma della salvezza, in Illusione e paura nel mondo borghese. Da Dickens a Orwell, Bari 1968.
M.T. Chialant, Dickens, Gissing e Orwell, in «Annali dell'Istituto Uni-versitario Orientale di Napoli», sezione Germanica, 12, 1969.
E. Croce, George Orwell, in «Settanta», 22, marzo 1972.
G. Zanmarchi, Invito alla lettura di George Orwell, Milano 1975.
F. Moretti, Letteratura e ideologie negli anni Trenta inglesi, Bari 1976.
F. Marroni, The Road to Wigan Pier: fallimento di una ricerca, in «Studi inglesi», V, 1978. F. Livorsi, Utopia e totalitarismo. George Orwell, Mau-rice Merleau-Ponty e la storia della rivoluzione russa da Lenin a Stalin, Torino 1979.
S. Manferlotti, George Orwell, Firenze 1979. F. Ferrara, La lotta controil leviatano. L'analisi dei sistemi culturali e dei conflitti fra individuo e potere nell'opera narrativa di George Orwell, Napoli 1981. R. Williams, Orwell, Milano 1990.
B. Crick, George Orwell, Bologna 1991.
Inoltre: la prefazione di G. Monicelli George Orwell, scrittore del nostrotempo per La fattoria degli animali, Milano 1947; la presentazione di G.
Zanmarchi per Giorni in Birmania, Milano 1975; la prefazione di E. Gia-chino per la raccolta di saggi e scritti miscellanei Tra sdegno e passione, Milano 1977.
1984
PARTE PRIMA
I
Era una luminosa e fredda giornata d'aprile, e gli orologi battevano tre-dici colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli Appartamenti Vittoria: non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui.
L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi e logori stoini.
A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per
poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa quarantacinque anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della Settimana dell'Odio, durante le ore diurne l'ero-gazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al set-timo piano e Winston, che aveva trentanove anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. IL
GRANDE FRATELLO VI GUARDA, diceva la scritta in basso.1
All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio (si chiamava teleschermo) poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra: era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del Partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso.
Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuava-no i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve ne era uno proprio sulla facciata della casa di fronte.
IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA, diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato a uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola: SOCING. In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui, tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia, che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non
avevano molta importanza. Solo la Psicopolizia contava.
Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del Nono Piano Triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse emesso un suono anche appena appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato; inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione. Con quale frequen-za, o con quali sistemi, la Psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osser-vasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere (e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto) presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento — che non fosse fatto al buio — attentamente scrutato.
Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro2 di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista Uno, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti ricoperti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano, inclinandosi da tutte le parti? E le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano di-sordinatamente sui mucchi delle macerie, e i posti dove le bombe avevano creato spazi più ampi, lasciando spuntare colonie di case di legno simili a tanti pollai? Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi.
Il Ministero della Verità (Miniver, in neolingua) differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere.
Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che s'innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di trecento metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca
facciata in eleganti caratteri, i tre slogan del Partito: LA GUERRA È PACE
LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ
L'IGNORANZA È FORZA
Si diceva che il Ministero della Verità contenesse tremila stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli i fabbricati circostanti, che dal tetto degli Appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente.
Erano le sedi dei quattro Ministeri fra i quali era distribuito l'intero appara-to governativo: il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti; il Ministero della Pa-ce, che si occupava della guerra; il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico; e il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Minipax, Miniamor e Miniabb.
Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre. Winston non vi era mai entrato, anzi non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pat-tugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli.
Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina.
Uscendo a quell'ora dal Ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca: GIN VITTORIA. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese.
Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi l'ingoiò come se si trattasse di una medicina.
La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano dagli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava, era
come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgual-cito con la scritta SIGARETTE VITTORIA e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva.
Ritornò nel soggiorno e si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo. Tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata.
Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita: invece che nella parete di fondo, com'era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori del raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione, non era possibile vederlo e, forse, proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare.
Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena ingiallita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno quarant'anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattie re in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato il nome, ed era stato immediatamente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini, i membri del Partito non potevano entrare nei negozi normali (un'azione del genere veniva definita "fare acquisti al libero mercato"), ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano diverse cose, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo due dollari e cinquanta centesimi. In quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa: anche se non vi era scritto niente, era
un oggetto compromettente.
Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé (nulla era illegale, dal momento che non esistevano più leggi), ma si poteva ragionevolmente presumere che, se lo avessero scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con venticinque anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento anti-quato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero, e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezion fatta per appunti bre-vissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto de-finitivo, cruciale. A lettere piccole e goffe scrisse: 4 aprile 1984.
Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere trentanove anni, di essere nato nel 1944 o 1945, ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due.
Per chi, si chiese a un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro, per gli uomini non ancora nati. La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina, poi andò a cozzare contro la parola in neolingua bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse teme-rario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per se stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso, e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso.
Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più che cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento, e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio.
L'atto della scrittura sarebbe stato facile. Non avrebbe dovuto fare altro che
riportare sulla carta quel monologo diuturno e inquieto che da anni, letteralmente, gli scorreva nella mente. Ora, però, anch'esso si era prosciugato.
L'ulcera varicosa, inoltre, aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché, a farlo, si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin.
All'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascu-rando le maiuscole, poi anche i punti fermi.
4 aprile 1984. Ieri sera al cinema. Solo film di guerra. Uno ottimo diuna nave piena di rifugiati bombardata da qualche parte nel Mediterrane-o. Il pubblico molto divertito dalla scena di un grassone grande e grossoche cercava di sfuggire a un elicottero che lo inseguiva. Lo si vedeva prima sguazzare nell'acqua come un delfino, poi attraverso i congegni di mi-ra dell'elicottero, dopodiché era pieno di buchi e il mare attorno a lui diventava rosa ed egli affondava all'improvviso come se i buchi avessero fatto entrare l'acqua. il pubblico dette in grosse risate quando l'uomo affon-dò. poi si vedeva una scialuppa di salvataggio piena di bambini con un elicottero che le volteggiava sopra. c'era una donna di mezz'età forse un'ebrea seduta a prua con un bambino di tre anni fra le braccia. il bambinostrillava dalla paura e nascondeva la testa fra i seni della madre come sevolesse scavarsi un rifugio nel suo corpo e la donna lo abbracciava e loconfortava anche se era anch'essa folle di terrore, coprendolo per quantopoteva come se le sue braccia potessero allontanare da lui i proiettili. poil'elicottero sganciò una bomba da 20 chili che li prese in pieno un bagliore terribile poi la barca volò in mille pezzi. poi ci fu una bellissima inqua-dratura del braccio di un bambino che andava su su su nell'aria dovevaaverlo seguito un elicottero con una cinepresa sul muso e uno scroscio diapplausi si levò dai posti riservati ai membri del Partito ma una donna nelsettore destinato ai prolet cominciò a fare un gran baccano gridando chenon dovevano far vedere queste cose ai bambini no finché la polizia nonl'ha buttata fuori credo che non le sia successo nulla nessuno si preoccupadi quello che dicono i prolet era stata una reazione tipica dei prolet loronon...
Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo alla mano. Non sapeva che cosa lo avesse indotto a buttar giù quella robaccia, ma il fatto curioso era che mentre scriveva gli era affiorato alla mente un ricordo del tutto diverso, in maniera così nitida che quasi sentiva di poterlo descrivere con accuratezza. Anzi, ora si rendeva conto che era stato proprio quell'avvenimento a spingerlo a tornare a casa in anticipo e a dare inizio al suo diario.
Era accaduto (sempre che si potesse dire che un qualcosa di così indistinto fosse realmente accaduto) quella mattina al Ministero.
Erano quasi le undici e nell'Archivio dove lavorava Winston stavano tirando le sedie fuori dai cubicoli per raggnipparle al centro della sala, di fronte al grande teleschermo, in preparazione dei Due Minuti d'Odio. Winston stava giusto prendendo posto in una delle file centrali, quando ina-spettatamente erano entrate due persone che lui conosceva di vista, ma a cui non aveva mai rivolto la parola. Una era una ragazza che aveva spesso incontrato nei corridoi. Ne ignorava il nome, ma sapeva che lavorava al Reparto Finzione. Forse (infatti l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano, le dita unte di grasso) aveva qualche incarico di natura puramente meccanica relativo a una di quelle macchine scrivi-romanzi.
Era una ragazza dall'aria risoluta, di circa ventisette anni, folti capelli neri, la faccia punteggiata di lentiggini e movimenti rapidi, atletici. Una sottile fascia scarlatta, simbolo della Lega Giovanile Antisesso, le girava più volte intorno alla vita, sufficientemente stretta per mettere in mostra la forma armoniosa dei fianchi. Winston l'aveva detestata dal primo momento in cui l'aveva vista, e sapeva anche il perché: era a motivo di quell'aria da campi di hockey, bagni freddi, gite di gruppo e indefettibile rigore morale che emanava dalla sua persona. Detestava quasi tutte le donne, soprattutto quelle giovani e graziose. Erano infatti le donne — e specialmente le più giovani — a fornire al Partito i suoi affiliati più bigotti, pronte com'erano a ingoiare ogni slogan, a prestarsi a fare le spie dilettanti e le scopritrici dei comportamenti eterodossi. Questa ragazza, in particolare, gli dava l'impressione di essere più pericolosa delle altre. Una volta, mentre percorrevano il corridoio, lei gli aveva lanciato una rapida occhiata obliqua, come se volesse attraversarlo da parte a parte. Per un istante si era sentito prendere dal terrore. Aveva perfino pensato che potesse essere un'agente della Psicopolizia, anche se la cosa era assai improbabile. In ogni caso, tutte le volte che la ragazza si trovava nelle sue vicinanze, lui continuava ad avvertire un certo disagio, un misto di paura e ostilità.
L'altra persona era un uomo di nome O'Brien, membro del Partito Interno e titolare di un qualche incarico così importante e inattingibile, che Winston se ne poteva fare solo un'idea vaga. Per un attimo, nel vedere l'uniforme nera di un membro del Partito Interno che si avvicinava, un mormorio percorse le file di quanti si affaccendavano attorno alle sedie. O-
'Brien era un uomo corpulento, tarchiato, con il collo largo, il volto tozzo e brutale, ma non privo di una certa arguzia. Malgrado l'aspetto terrificante, i suoi modi erano garbati. Aveva il vezzo di riaggiustarsi di continuo gli occhiali sul naso: un gesto curiosamente disarmante perché, per qualche strano motivo, lo si associava a una persona beneducata; un gesto che, se fosse stato possibile pensare in questi termini, avrebbe potuto evocare un genti-luomo del Settecento che offrisse una presa dalla sua tabacchiera. Winston lo aveva visto sì e no una dozzina di volte in altrettanti anni. Si sentiva profondamente attratto da lui, e non solo perché era incuriosito dal contrasto fra i modi urbani che esibiva e il suo fisico da pugile. Molto più lo affascinava la segreta convinzione (ma forse era una speranza, più che una convinzione) che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse perfetta. Qualcosa nel suo volto pareva suggerirlo in maniera irresistibile. O forse a essergli stampata in faccia non era tanto l'eterodossia ma, semplicemente, l'intelligenza. In ogni caso, sembrava una persona con cui fosse possibile discutere, ammesso che si riuscisse a ingannare il teleschermo e trovarsi faccia a faccia con lui. Winston non aveva mai tentato, neanche minimamente, di verificare la veridicità della sua ipotesi. In realtà, non ce n'era neanche il modo. In quel momento O'Brien dette un'occhiata al suo orologio, vide che erano quasi le undici e fu chiaro che aveva deciso di trattenersi nell'Archivio fino alla fine dei Due Minuti d'Odio. Si sedette nella stessa fila di Winston, a un paio di posti di distanza da lui. Li divideva una donna minuta, dai capelli color sabbia, che lavorava nel cubicolo accanto a quello di Winston. La ragazza dai capelli neri era seduta proprio dietro di loro.
Un attimo dopo, dal teleschermo in fondo alla sala esplose uno stridio lacerante, terribile, come se a produrlo fosse stata una qualche mostruosa macchina mal lubrificata, un rumore che allegava i denti e faceva rizzare i capelli in testa. L'Odio era cominciato.
Come al solito, era apparso sullo schermo il volto di Emmanuel Goldstein, il Nemico del Popolo. Dal pubblico venne qualche fischio. La donna dai capelli color sabbia emise una specie di gemito, nel quale si mesco-lavano paura e disgusto. Goldstein era l'apostata, il traditore che tanto, tan-
to tempo fa (nessuno ricordava quanto) era stato una personalità fra le più insigni del Partito, addirittura quasi allo stesso livello del Grande Fratello, ma poi si era impegnato in attività controrivoluzionarie ed era stato con-dannato a morte. Dopodiché era evaso e misteriosamente scomparso. Il programma dei Due Minuti d'Odio cambiava ogni giorno, ma Goldstein ne era sempre l'interprete principale. Era il traditore per antonomasia,3 il primo ad aver contaminato la purezza del Partito. Tutti i crimini commessi successivamente contro il Partito, tutti i tradimenti, gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, erano un'emanazione diretta del suo credo. Egli era tuttora vivo in qualche parte del mondo, a tramare le sue cospirazioni. Forse si trovava in qualche Paese al di là del mare, al soldo e sotto la protezione dei suoi padroni stranieri. Forse, così correva talvolta voce, se ne stava nascosto nella stessa Oceania.
Winston avvertì una stretta al diaframma. Non riusciva a guardare la faccia di Goldstein senza provare un miscuglio di emozioni che gli dava sofferenza. Goldstein aveva uno scarno volto da ebreo, incorniciato da u-n'ampia e crespa aureola di capelli bianchi e da una barbetta caprina: un volto intelligente e però in qualche modo spregevole, al quale il naso lungo e sottile, su cui poggiava un paio di occhiali, conferiva una certa aria di demenza senile. Sembrava la faccia di una pecora, e anche la voce somigliava a un belato. Ora Goldstein stava rivolgendo il solito attacco veleno-so alle dottrine del Partito, un attacco così eccessivo e iniquo che non avrebbe tratto in inganno neanche un bambino e purtuttavia plausibile quanto bastava a trasmettere l'allarmante sensazione che potesse far presa su persone sufficientemente credule e ingenue. Insultava il Grande Fratello, denunciava la dittatura del Partito, esigeva la rottura immediata della pace con l'Eurasia, chiedeva a gran voce libertà di espressione, libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di pensiero, con toni isterici urlava che la Rivoluzione era stata tradita, parlando concitatamente ed esprimendosi in uno stile polisillabico che suonava come una parodia del modo di parlare tipico dei membri del Partito e nel quale non mancava, addirittura, qualche parola in neolingua. A dire il vero, ne conteneva più di quante un membro del Partito ne avrebbe usate normalmente. Nel frattempo sul teleschermo alle sue spalle, per sciogliere ogni dubbio sui fini reconditi del suo capzio-so sproloquio, marciavano le sterminate colonne dell'esercito eurasiatico: una fila dopo l'altra di uomini massicci, con inespressive facce asiatiche, che passavano a ondate sulla superficie dello schermo e poi sparivano, solo per essere subito sostituiti da altri uomini perfettamente uguali a loro. Il
passo battuto dagli stivali dei soldati, monotono e ritmato, faceva da sfondo sonoro alla voce belante di Goldstein.
L'Odio era iniziato da meno di trenta secondi e già da una buona metà dei presenti prorompevano incontrollabili manifestazioni di collera. Quella tronfia faccia ovina sul teleschermo e la terribile possanza dell'esercito eurasiatico alle sue spalle andavano al di là di ogni limite di sopportazione.
In aggiunta a ciò, la vista di Goldstein, o addirittura il solo pensare a lui, producevano automaticamente sentimenti di paura e di rabbia. Goldstein costituiva un oggetto costante d'odio, anche più dell'Eurasia o dell'Estasia, perché quando l'Oceania era in guerra con una di queste potenze, in genere era in pace con l'altra. E però era strano che, sebbene Goldstein fosse il bersaglio dell'odio e del disprezzo collettivo, sebbene ogni giorno e per migliaia di volte, dall'alto di un podio o da un teleschermo, in libri o giornali, le sue teorie venissero confutate, fatte a pezzi, ridicolizzate ed esposte al pubblico ludibrio per quella spazzatura che erano, malgrado tutto ciò, la sua influenza non sembrava subire colpi. Vi erano sempre dei gonzi nuovi in attesa di essere sedotti da lui, né passava giorno senza che la Psicopolizia smascherasse spie e sabotatori che agivano sotto le sue direttive. Era il comandante in capo di un enorme esercito ombra, di una rete sotterranea di cospiratori votati al sovvertimento dello Stato. Pare che si chiamasse la Confraternita. Si mormorava anche dell'esistenza di un libro terribile, una sorta di compendio di tutte le eresie, di cui Goldstein era l'autore e che cir-colava in copie clandestine. Non aveva titolo. Per la gente era, semplicemente, il libro. Ma queste cose erano soltanto il frutto di dicerie indistinte: a meno che non fosse impossibile evitarlo, tanto la Confraternita che illibro erano argomenti che nessun membro ordinario del Partito avrebbe mai menzionato. Nel secondo minuto, l'Odio raggiunse il parossismo. I presenti si sedevano e balzavano in piedi di continuo, urlando con tutte le loro forze nel tentativo di coprire l'esasperante belato che proveniva dal teleschermo; la donna dai capelli color sabbia si era fatta tutta rossa in faccia, mentre la bocca le si apriva e chiudeva come quella di un pesce tirato fuori dall'acqua. Perfino il tozzo volto di O'Brien si era infiammato. Sedeva ben dritto al suo posto, col petto poderoso che si gonfiava e fremeva come se dovesse reggere l'impatto di un'onda. La ragazza dai capelli neri che sedeva alle spalle di Winston aveva cominciato a urlare: «Porco! Porco! Porco!». A un tratto afferrò un pesante dizionario di neolingua e lo scagliò contro lo schermo: il volume colpì il naso di Goldstein, poi rimbal-zò via, mentre la voce seguitava inesorabilmente a farsi sentire. In un mo-
mento di lucidità Winston si rese conto che stava gridando come tutti gli altri, battendo con forza il tallone contro il piolo della sedia. La cosa orribile dei Due Minuti d'Odio era che nessuno veniva obbligato a recitare.
Evitare di farsi coinvolgere era infatti impossibile. Un'estasi orrenda, indotta da un misto di paura e di sordo rancore, un desiderio di uccidere, di torturare, di spaccare facce a martellate, sembrava attraversare come una corrente elettrica tutte le persone lì raccolte, trasformando il singolo individuo, anche contro la sua volontà, in un folle urlante, il volto alterato da smorfie. E tuttavia, la rabbia che ognuno provava costituiva un'emozione astratta, indiretta, che era possibile spostare da un oggetto all'altro come una fiamma ossidrica. Così, un istante dopo, l'odio di Winston non era più rivolto contro Goldstein, ma contro il Grande Fratello, il Partito e la Psicopolizia. In momenti simili il suo affetto andava a quel solitario e deriso eretico sullo schermo, difensore unico della verità e della sanità mentale in un mondo di menzogne. Passava un altro istante, e Winston si ritrovava in perfetta sintonia con quelli intorno a lui e tutto ciò che si diceva di Goldstein gli sembrava vero. Allora l'intimo disgusto che avvertiva nei confronti del Grande Fratello si mutava in adorazione e il Grande Fratello pareva sollevarsi ad altezze vertiginose, protettore invincibile e impavido, immoto come una roccia davanti alle orde dell'Asia, e Goldstein, a dispetto del suo isolamento, della sua impotenza e dei dubbi che avvolgevano la sua stessa esistenza, appariva come un sinistro incantatore, capace di abbattere l'edificio della civiltà con la sola forza della sua voce.
In qualche momento era perfino possibile dirigere il proprio odio da una parte all'altra, assecondando un atto libero della volontà. All'improvviso, col medesimo sforzo con cui si solleva la testa dal cuscino quando si vuole uscire da un incubo, Winston riusciva a trasferire il suo odio dal volto sullo schermo alla ragazza dai capelli neri seduta dietro di lui. Allucinazioni vi-vide, splendide, gli attraversavano la mente: la bastonava a morte con un manganello di caucciù, la legava nuda a un palo e la trapassava con un nu-golo di frecce, come san Sebastiano, la violentava, sgozzandola al momento dell'orgasmo. In casi del genere capiva anche perché la odiava. La odiava perché era giovane, bella e frigida, perché voleva andare a letto con lei e questo non sarebbe mai stato possibile, perché attorno alla sua vita mor-bida e flessuosa, che sembrava chiedere di essere abbracciata, girava quella odiosa fascia scarlatta, simbolo di un'aggressiva castità.
L'Odio raggiunse il culmine. La voce di Goldstein era diventata adesso un belato a tutti gli effetti. Per un istante la sua faccia si trasformò in quella
di una pecora, che a sua volta si dissolse nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava, enorme e spaventevole, sparando raffiche dalla mitragliatrice. Parve anzi che il soldato fuoriuscisse dallo schermo, tanto che alcuni di quelli che occupavano la prima fila fecero un balzo all'indietro sui sedili. Nello stesso momento, però, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo, la sua minacciosa figura si dissolse per lasciare il posto al volto del Grande Fratello, i capelli e i baffi neri, irraggiante forza e una misteriosa serenità. Così grande che quasi riempiva lo schermo. Nessuno udì quello che il Grande Fratello stava dicendo. Erano solo parole d'incoraggiamento, di quelle che si dicono nel fragore della battaglia, impossibili a distinguersi, ma che fanno riacquistare fiducia per il solo fatto di essere pronunciate.
Poi anche il suo volto si dissolse, per lasciare il posto ai tre slogan del Partito, vergati in lettere maiuscole:
LA GUERRA È PACE
LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ
L'IGNORANZA È FORZA
Il volto del Grande Fratello parve però indugiare per diversi secondi sullo schermo, come se l'impatto che aveva esercitato sulle pupille dei presenti fosse troppo intenso per poter essere eliminato all'improvviso. La donna dai capelli color sabbia, allungandosi al di sopra del sedile che aveva davanti, tese le braccia verso lo schermo e mosse le labbra in un tremulo bisbiglio nel quale parve di poter distinguere le parole «Mio salvatore!», dopodiché nascose il volto fra le mani. Era chiaro che stava pregando.
In quel momento tutti intonarono una sorta di salmodia lenta, ritmata, solenne: «G.F.!... G.F.!... G.F.!» incessantemente, lentamente, con una lunga pausa fra la G e la F, un murmure sordo e in un certo senso selvaggio, nel cui fondo sembrava di udire il battito cadenzato di piedi nudi e le vibrazioni dei tam-tam. Continuarono a cantare per quasi trenta secondi, seguendo un rituale che si ripeteva quasi tutte le volte in cui l'emozione si faceva particolarmente forte. Si trattava in parte di un inno alla saggezza e alla maestà del Grande Fratello, ma soprattutto di un atto di autoipnosi, di un volontario ottundimento della coscienza, raggiunto per mezzo del ritmo. Winston avvertì un gelo alle viscere. Durante i Due Minuti d'Odio non poteva sottrarsi al delirio generale, ma questo canto primitivo, «G.F.!...
G.F.!», lo riempiva sempre di orrore. Naturalmente, cantava come tutti gli altri, era impossibile fare altrimenti: dissimulare i propri sentimenti, con-
trollare i movimenti del volto, fare quello che facevano gli altri, era una reazione istintiva. Ciononostante, vi fu uno spazio di un paio di secondi durante i quali l'espressione dei suoi occhi avrebbe potuto tradirlo, e fu proprio allora che la cosa accadde, ammesso che davvero fosse accaduta.
Per un attimo Winston incrociò lo sguardo di O'Brien. Questi si era levato in piedi, si era tolto gli occhiali e se li stava risistemando sul naso col suo gesto caratteristico. Ci fu tuttavia una frazione di secondo in cui i loro occhi si incontrarono e in quel brevissimo arco di tempo Winston seppe (sì, seppe) che O'Brien stava pensando le stesse cose che stava pensando lui. Era stato inviato un messaggio inequivocabile. Era come se le loro menti si fossero aperte e i pensieri fluissero, attraverso gli occhi, dall'uno all'altro. "Sono con te" sembrava dirgli O'Brien, "so esattamente quello che provi, so tutto del tuo disprezzo, del tuo odio, del tuo disgusto, ma non temere, io sono dalla tua parte!" Poi quel lampo di mutua intesa si era spento e il volto di O'Brien era tornato imperscrutabile come quello di tutti gli altri.
Questo era tutto, e Winston già dubitava che fosse successo davvero.
Fatti del genere non avevano mai un seguito. Gli servivano solo a tenere viva la convinzione, o la speranza, che oltre a lui ci fossero altri nemici del Partito. Forse ciò che si vociferava di complotti clandestini era vero, forse la Confraternita esisteva sul serio! Nonostante i continui arresti, confessioni ed esecuzioni capitali, non si poteva essere certi che la Confraternita fosse solo una favola. Winston in certi giorni ci credeva, in altri no. Prove non ne esistevano. Solo tracce incertissime, che potevano significare tutto e nulla: brandelli di conversazione colti di sfuggita, scritte indistinte sulle pareti dei gabinetti pubblici. .. una volta gli era addirittura capitato, quando aveva visto due sconosciuti incontrarsi, di cogliere in loro un impercettibile movimento delle mani che avrebbe potuto essere un segnale di riconoscimento. Null'altro che congetture, frutto, forse, della sua immaginazione.
Era tornato al suo cubicolo senza volgere più lo sguardo a O'Brien. L'idea di dare un seguito al loro effimero contatto non gli passò neanche per la mente. Sarebbe stato pericolosissimo, anche ammettendo che avesse saputo come mettere in pratica un simile progetto. Per un secondo, forse due, si erano scambiati un'occhiata strana ed enigmatica, tutto qui. Ma perfino una cosa del genere costituiva un evento memorabile nella vita di solitaria se-gregazione in cui si era costretti a vivere.
Winston si scosse da quei pensieri e raddrizzò la schiena. Ruttò: il gin gli stava risalendo dallo stomaco.
Volse di nuovo lo sguardo alla pagina, per scoprire che durante le sue vane fantasticherie aveva continuato a scrivere, automaticamente. E non si trattava più della grafia goffa e incerta di prima. La penna era scivolata voluttuosamente sulla carta levigata, vergando in chiare e grandi maiuscole le parole:
ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!
ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!
ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!
ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!
ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!
e così via, fino a riempire una mezza pagina.
Non poté impedirsi di sentire una fitta di panico. Si trattava di una reazione assurda, perché quelle parole non erano di per sé più pericolose della decisione iniziale di cominciare un diario, eppure per un attimo Winston ebbe la tentazione di strappare le pagine contaminate e rinunciare alla sua impresa.
Non lo fece perché sapeva che era inutile. Che scrivesse o meno ABBASSO IL GRANDE FRATELLO!, non faceva differenza alcuna. Che continuasse o meno a tenere il diario, non faceva differenza alcuna: la Psicopolizia lo avrebbe preso lo stesso. Aveva commesso (e l'avrebbe fatto anche se non l'avesse mai messo nero su bianco) quel reato fondamentale che conteneva dentro di sé tutti gli altri. Lo chiamavano psicoreato. Era un delitto che non si poteva tenere celato per sempre: potevate scamparla per un po', anche per anni, ma era sicuro al cento per cento che prima o poi vi avrebbero preso.
Accadeva sempre di notte. Gli arresti venivano eseguiti sempre di notte: il risveglio improvviso e violento, una mano brutale che vi scuoteva la spalla, la luce delle torce elettriche che vi abbagliava gli occhi, il cerchio di facce dure intorno al letto. Nella gran parte dei casi non si celebravano processi, né si stendevano resoconti dell'arresto. La gente semplicemente spariva, e sempre di notte. Il nome dell'arrestato veniva cancellato dagli archivi, ogni traccia di quello che aveva fatto nel corso della sua vita veniva rimossa, la sua stessa esistenza di un tempo veniva prima negata, quindi dimenticata. L'arrestato era eliminato, annientato. La parola giusta era vaporizzato. Per un attimo lo prese una sorta di frenesia isterica. Cominciò a scrivere, scarabocchiando in fretta e alla bell'e meglio le seguenti parole:
mi spareranno non me ne importa nulla mi tireranno un colpo alla nucanon me ne importa nulla abbasso il grande fratello ti tirano sempre uncolpo alla nuca non me ne importa nulla abbasso il grande fratello...
Si appoggiò allo schienale della sedia, un po' vergognandosi di se stesso, e posò la penna. Un attimo dopo trasalì violentemente. Qualcuno stava bussando alla porta.
Erano già qui! Restò seduto, immobile come un topo, nella futile speranza che, chiunque fosse, potesse andare via dopo il primo tentativo. Ma non fu così, si udì di nuovo bussare. Indugiare sarebbe stata la cosa peggiore. Il cuore gli batteva in petto come un tamburo, ma probabilmente, in virtù della lunga abitudine, la faccia era rimasta priva di qualsiasi espressione. Si alzò, avviandosi a passi pesanti verso la porta.
II
Mentre stava per spingere la maniglia della porta, Winston si accorse di aver lasciato il diario aperto sul tavolo. Le parole ABBASSO IL GRANDE
FRATELLO! lo percorrevano in lungo e in largo e le lettere erano così grandi che potevano essere lette da un capo all'altro della stanza. Non avrebbe potuto fare una cosa più stupida. Tuttavia si rese conto che neanche il panico aveva potuto indurlo a imbrattare quella bella carta vellutata, chiudendo il quaderno quando l'inchiostro non si era ancora asciugato.
Trattenne il respiro e aprì la porta. Immediatamente un'ondata di sollievo lo avvolse. Sulla soglia vi era una donnetta insignificante, dall'aria disfatta, i capelli troppo sottili e una faccia piena di rughe.
«Compagno» cominciò a dire in un tono di voce monotono e lamentoso,
«mi era parso di sentire che eri rientrato. Potresti venire a dare un'occhiata al lavello della cucina? Si è otturato e...»
Era la signora Parsons, la moglie di un vicino che abitava sullo stesso piano. (Per la verità, il Partito non approvava l'uso della parola "signora".
Nel rivolgersi agli altri si dovevano utilizzare gli appellativi "compagno" e
"compagna", ma con alcune donne la parola "signora" si usava istintiva-mente.) Era una donna sui trent'anni, ma ne dimostrava molti di più. Si aveva l'impressione che le rughe del volto fossero piene di polvere. Winston la seguì sul ballatoio. Queste riparazioni estemporanee erano una seccatura quasi quotidiana. Gli Appartamenti Vittoria erano case vecchie, costruite
prima del 1930, e cadevano a pezzi. L'intonaco si staccava continuamente dalle pareti, le condutture scoppiavano a ogni gelata, dal tetto colava acqua tutte le volte che nevicava, il riscaldamento funzionava a scartamento ridotto, sempre che per motivi di risparmio non fosse spento del tutto. Le riparazioni, nel caso non foste in grado di provvedere da soli, dovevano ricevere l'approvazione di commissioni misteriose, che potevano differire di un paio d'anni perfino la riparazione del vetro di una finestra.
«Scusa se ti disturbo» disse la signora Parsons con una certa indecisione nella voce, «ma Tom non è in casa.»
L'appartamento dei Parsons era più grande di quello di Winston, ma ciò che lo distingueva dal suo era un diverso tipo di squallore. Sembrava che ogni oggetto fosse stato battuto e calpestato, come se nella casa avesse im-perversato un qualche grosso animale. Sul pavimento erano sparsi attrezzi e indumenti sportivi (bastoni da hockey, guanti da pugilato, un pallone sgonfio, un paio di calzoncini sudati e girati alla rovescia), mentre il tavolo ospitava, nella più grande confusione, una messe di piatti sporchi e qua-derni sgualciti. Alle pareti, gli stendardi rossi della Lega della Gioventù e delle Spie, e un manifesto a grandezza naturale del Grande Fratello. Si respirava il solito fetore di cavolo bollito che avvolgeva l'intero fabbricato, ma a questo si sovrapponeva il lezzo del sudore di una persona che in quel momento era assente. Lo si avvertiva nelle narici, anche se non si riusciva a capire come fosse possibile una cosa del genere. In un'altra stanza qualcuno stava tentando, con un pettine e un pezzo di carta igienica, di andare a tempo con la musica militare proveniente dal teleschermo.
«Sono i bambini» disse la signora Parsons, gettando uno sguardo leggermente inquieto alla porta. «Oggi non sono usciti, e allora...»
Aveva l'abitudine di lasciare sempre le frasi a metà. Il lavello della cucina era pieno fin quasi all'orlo di una sporca acqua verdastra che puzzava perfino più del cavolo. Winston s'inginocchiò ed esaminò la giuntura ad angolo del tubo. Odiava usare le mani nude, odiava inginocchiarsi, perché questo lo faceva sempre tossire. La signora Parsons stava a guardare con aria impotente.
«Se Tom fosse in casa, lo aggiusterebbe in un momento» disse. «Adora fare queste cose. Nei lavori manuali è bravissimo.»
Parsons lavorava con Winston al Ministero della Verità. Era un uomo grassoccio ma dinamico, di una stupidità sconfortante, un concentrato di entusiasmo imbecille, uno di quegli sgobboni adoranti e votati alla più cieca obbedienza sui quali, più ancora che sulla Psicopolizia, si reggeva la
stabilità del Partito. All'età di trentacinque anni l'avevano buttato fuori, re-calcitrante, dalla Lega della Gioventù, ma prima di ricevere il suo bravo diploma era riuscito a restare nel corpo delle Spie per un anno in più di quelli previsti dallo statuto. Al Ministero era impiegato in qualche lavoro subordinato per il quale l'intelligenza non era requisito indispensabile. Era però una figura di primo piano nel Comitato Sportivo e in tutti quei comi-tati che organizzavano gite in comitiva, dimostrazioni spontanee, campa-gne per il risparmio dì questo o di quello e attività di volontariato in genere. Con sereno orgoglio, fra un tiro e l'altro di pipa, v'informava che negli ultimi quattro anni non aveva mai mancato di fare una puntatina, la sera, al Centro Sociale. Un invincibile lezzo di sudore, quasi un'inconscia testimo-nianza della sua indefessa attività, lo seguiva dovunque andasse e restava dietro di lui quando si allontanava.
«Hai una chiave inglese?» domandò Winston, armeggiando col dado della giuntura.
«Una chiave inglese?» replicò la signora Parsons, afflosciandosi. «Non sono sicura, non so, forse i bambini...»
Uno scalpiccio di piedi e un'altra soffiata di pettine accompagnarono l'entrata dei bambini in soggiorno. La signora Parsons arrivò con la chiave inglese. Winston fece defluire l'acqua e con un moto di disgusto rimosse il gomitolo di capelli che aveva intasato il tubo. Si pulì alla meglio le mani sotto l'acqua corrente e tornò nell'altra stanza.
«Mani in alto!» strillò una voce selvaggia.
Un bel bambino di nove anni dall'aria minacciosa era balzato da dietro il tavolo, puntandogli contro una pistola giocattolo, mentre la sorellina, di un paio d'anni più piccola, faceva lo stesso gesto con un pezzo di legno. Indossavano entrambi l'uniforme delle Spie, vale a dire calzoncini azzurri, camicie grigie e fazzoletti rossi al collo. Winston alzò le mani sul capo, ma con un certo disagio: i modi del bambino erano così rabbiosi, che quasi non sembrava un gioco.
«Sei un traditore!» urlò il bambino. «Sei uno psicocriminale, una spia eurasiatica! Ti sparo, ti vaporizzo, ti mando alle miniere di sale!»
All'improvviso si misero a saltargli intorno, gridando: «Traditore», «Psicocriminale!», con la bambina che imitava tutti i movimenti del fratello.
La scena incuteva un certo timore, come se si trattasse del ruzzare di cuc-cioli di tigre, destinati a crescere in fretta e a diventare mangiatori d'uomini. Nello sguardo del bambino si poteva scorgere una sorta di deliberata ferocia, il desiderio palese di colpire o prendere a calci Winston, unito alla
consapevolezza che presto avrebbe avuto la corporatura giusta per compiere un'azione del genere. Fortuna, pensò Winston, che non aveva in mano una pistola vera.
Lo sguardo della signora Parsons andava nervosamente da Winston ai bambini e dai bambini a Winston. Alla luce più intensa del soggiorno, Winston si accorse che nelle rughe del suo volto vi era davvero della polvere.
«Stanno facendo tutto questo chiasso» disse «perché non sono potuti andare a vedere l'impiccagione. Io ho troppo da fare per accompagnarli, e Tom torna troppo tardi dal lavoro.»





























