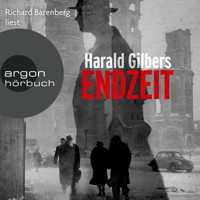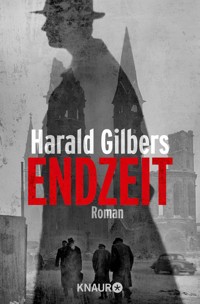Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
La guerra è finita e Berlino, nella morsa del gelo e della fame, cerca di voltare pagina. Ma l'ombra del passato incombe su un presente ancora incerto. Un angelo vendicatore sta lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Una lunga lista di nomi è incisa sulla loro pelle. Toccherà a Oppenheimer risalire all'origine degli omicidi, a quel terribile segreto da cui tutto ha avuto inizio, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più labile.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Questo libro è un’opera della fantasia. I nomi, i personaggi e gli eventi sono il frutto dell’immaginazione dell’autore. Qualunque somiglianza con persone vive o defunte, luoghi o fatti reali è puramente casuale.
Dello stesso autore:
Berlino 1944. Caccia all’assassino tra le macerie
I figli di Odino. L’ex commissario Oppenheimer e la fine del Reich
Atto finale. L’ex commissario Oppenheimer e l’Armata Rossa a Berlino
Titolo originale: Totenliste
© 2018 Knaur Verlag. Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
© 2019 Emons Verlag GmbH
Tutti i diritti riservati
Italian edition by arrangement with Il Caduceo Agenzia Letteraria
Prima edizione: agosto 2019
Impaginazione: Rossella Di Palma
Elaborazione ebook: CPI Books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-578-7
Distribuito da Emons Italia S.r.l.
Viale della Piramide Cestia 1c
00153 Roma
www.emonsedizioni.it
HARALD GILBERS
LA LISTA NERA
L’ex commissario Oppenheimer e la resa dei conti
Traduzione di Angela Ricci
Personaggi principali
Richard Oppenheimer – ex commissario di polizia criminale, ebreo
Lisa Oppenheimer – moglie di Richard Oppenheimer
Hildegard von Strachwitz, detta Hilde – medico, amica di Richard Oppenheimer
Schmude – vecchio amico di Oppenheimer e Hilde
Colonnello Aksakov – ufficiale dell’NKVD
Jaša – ufficiale dell’Armata Rossa
Michalina – ex compagna di cella di Hilde
Ede – malfattore
Gerda – guardia del corpo e buttafuori di Ede
Georg Hüttner – ex fuoriuscito politico tedesco, ora funzionario sovietico
Josef Hüttner – fratello di Georg
Oswald Klinke – medico di Weydorf
Theo – bambino di strada, orfano
Irene Klee – studentessa
Billhardt – commissario di polizia, ex collega di Oppenheimer
Wenzel – aspirante ispettore, sottoposto di Billhardt
Reinmann – aspirante ispettore, sottoposto di Billhardt
Signor Furmannek – collega di Oppenheimer all’Ufficio Ricerche
Signor Suhr – capo di Oppenheimer all’Ufficio Ricerche
PROLOGO
Weydorf, zona di occupazione sovietica
Lunedì 6 maggio 1946
Oswald Klinke si bloccò di colpo, gli pareva di aver sentito qualcosa alle sue spalle. Un rumore che non apparteneva a quel luogo. Si guardò intorno in preda all’agitazione, ma non c’era granché da vedere, a parte le spighe verdi dell’orzo seminato in autunno. Il sole di maggio era stato coperto dal temporale incombente. Un improvviso colpo di vento portò con sé l’odore della pioggia, l’erba ondeggiò con un fruscio simile a quello delle onde del mare sotto un cielo plumbeo. In mezzo al campo, quasi con aria di sfida, si stagliava una figura dall’aspetto umano. Sotto il cappello il viso era privo di occhi e i vestiti a brandelli sventolavano sulle costole, che in realtà erano pezzi di legno. Klinke sapeva che il responsabile del rumore non poteva essere stato lo spaventapasseri. Gli oggetti inanimati non respirano, almeno non in maniera avvertibile.
Lo sconosciuto gli era già alle calcagna? Voleva sfruttare quell’occasione per colpire? Quel pensiero gli fece salire l’ansia. Era appena stato all’ennesimo funerale. Era la quarta volta da Pasqua che le campane del loro villaggio suonavano a morto, e in quel momento, da solo in mezzo al campo, capì che se non fosse stato attento ce ne sarebbe stata una quinta.
Era stato un errore imboccare il sentiero che conduceva direttamente a casa sua, invece di restare sulla strada principale. Fra gli altri abitanti sarebbe stato più al sicuro, lì al contrario, fuori dal villaggio, non poteva sperare nell’aiuto di nessuno.
Forse era meglio fingere di non aver notato il suo pedinatore, per fargli credere, così pensava Klinke, di avere l’elemento sorpresa dalla sua parte. Ostentando noncuranza si avvicinò a un albero sul bordo del sentiero e vi si appoggiò per allacciarsi le scarpe. In realtà osservava i dintorni.
Tentò inutilmente di normalizzare il respiro. Purtroppo il sangue freddo non rientrava fra i suoi tratti distintivi, almeno non quando era abbandonato a se stesso; quando non poteva contare su nessun altro e la sua sopravvivenza dipendeva esclusivamente da lui.
Almeno era preparato. Nella tasca interna del suo completo scuro c’era una pistola della Wehrmacht carica. Nei giorni caotici della sconfitta l’aveva trovata in un fosso poco lontano dal villaggio, insieme a un’uniforme. Lui era tedesco, e ufficialmente non avrebbe dovuto possedere armi. Se gli occupanti russi sospettavano qualcuno di essere un fedelissimo di Adolf Hitler, il poveretto veniva arrestato all’istante e poi spariva per sempre. Ma dal momento che i soldati russi si facevano vedere solo raramente nel villaggio, Klinke aveva ritenuto più sicuro recuperare l’arma dal suo nascondiglio e portarla con sé. In fin dei conti doveva pur difendersi in qualche modo.
Con lo sguardo fisso sulle spighe d’orzo ondeggianti, si preparò a estrarre l’arma non appena avesse visto una figura sconosciuta avvicinarsi.
In quanto unico medico del circondario, a Klinke spettava il compito di esaminare tutti i cadaveri, determinare le cause dei decessi, redigere i certificati di morte e avvisare la polizia nel caso in cui rilevasse qualcosa di strano. Aveva visto il segno, ma allora non era stato in grado di comprenderlo, e adesso che sapeva tutto, forse era già troppo tardi.
In tensione, attese che il suo pedinatore si rivelasse. Ma non accadde nulla. Poi sentì un altro rumore, un calpestio di zoccoli. Un cavallo trascinava un calesse sferragliante lungo il sentiero.
Tirò un sospiro di sollievo a quella vista. Il volto tondo dell’uomo a cassetta gli era familiare, si trattava dell’anziano signor Richter, i capelli tagliati alla bell’e meglio che gli spuntavano come al solito dalla falda del cappello. Indossava il vestito buono, e si faceva trasportare placidamente a casa dal suo ronzino. Non c’era motivo di affrettarsi quando si tornava da un funerale.
“Dottore, posso darle un passaggio?” chiese Richter dopo aver fermato il calesse.
Klinke accettò grato l’offerta e salì. Richter diede un lieve strattone alle redini per ordinare al cavallo di proseguire. Klinke si tolse il cappello per detergersi la fronte con il fazzoletto.
La sciagura che si era abbattuta sul villaggio sembrava un incubo. Il circondario gli era ancora familiare, conosceva tutti gli abitanti, eppure qualcosa era irrevocabilmente cambiato. Le certezze che aveva avuto fino a quel momento erano svanite.
Richter pareva immerso in pensieri analoghi, e dopo un po’ emise un brontolio scontento.
“Lo so,” mormorò Klinke per tutta risposta. “È già il quarto.”
“Il quarto… di noi,” precisò Richter.
Klinke rimase in silenzio e annuì.
Il primo morto di Weydorf era stato trovato in una stalla con il cranio sfondato, l’impronta di uno zoccolo sulla testa aveva fatto pensare a un incidente. Cinque giorni dopo l’incendio di un fienile aveva provocato la seconda vittima. I pompieri erano sotto organico, perché anche nel loro villaggio la maggior parte degli uomini in età da lavoro era partita per il fronte, e se non erano caduti per Hitler risultavano dispersi, oppure marcivano in uno degli innumerevoli campi di prigionia. Quindi era toccato ai pochi abitanti del villaggio rimasti unire le forze e accorrere a domare le fiamme.
All’appello mancava solo una persona: il proprietario del fienile. Poche ore dopo, il suo cadavere completamente carbonizzato era stato trovato fra le macerie fumanti. Già il giorno seguente a Weydorf era cominciata a girare la voce che ci fosse qualcosa di strano dietro quelle recenti disgrazie, e i due morti ravvicinati avevano confermato l’ipotesi. Nel caso della terza vittima, caduta sulla lama di una falce, si poteva ancora ipotizzare che si fosse trattato di un incidente, ma l’uomo che era stato sepolto quel giorno era stato ritrovato con la gola tagliata. Klinke non aveva più dubbi: tra di loro c’era un assassino all’opera.
Richter sapeva di poter essere assolutamente sincero con il dottore. Poche cose creavano un legame più stretto del custodire un segreto comune.
“Il maledetto non cerca nemmeno più di nascondere le sue tracce,” disse irritato. “Fa fuori i nostri senza battere ciglio e non gliene importa niente se qualcuno se ne accorge. Non capisco. Ha ordinato lei di lasciare la bara chiusa in chiesa?”
Klinke annuì cupo. “Che altro potevo fare? Dovevo rischiare di mettere in agitazione tutto il paese?”
Sarebbe stato pressoché impossibile nascondere la gola squarciata del morto sotto il colletto della camicia buona. La vista di quella ferita aveva perseguitato il dottore nei giorni precedenti, due labbra aperte sulla carne viva, che lo avevano deriso per tutto il tempo in cui aveva esaminato il cadavere.
“È quella la sua intenzione. L’assassino vuole che abbiamo paura di lui. Altrimenti perché quei graffiti?” aggiunse perdendo un po’ il filo del discorso.
Richter scosse energicamente il capo. “Ma quelle sono ragazzate. Dev’essere stato qualche monello del vicinato.”
Quando Klinke aveva fatto visita ai familiari della prima vittima per informarli della loro perdita aveva notato il marchio dell’assassino, un semplice segno inciso sulla porta di casa. Tuttavia, poiché a una prima occhiata i rozzi contorni del graffito non sembravano avere alcun significato, si era presto dimenticato persino di averlo visto.
L’orrore era sopraggiunto dopo, quando erano già arrivati a tre morti. Solo a quel punto si era reso conto. Attraversando con sguardo attento il paese, aveva notato che sulle case di tutte e tre le vittime si vedeva la stessa figura.
“Non credo a questo genere di coincidenze,” ribatté Klinke. “L’assassino sa perfettamente cosa è successo qui, e ci ritiene colpevoli. E adesso ci sta decimando, uno dopo l’altro.”
Tutto a un tratto il dottore ebbe l’impressione che gli mancasse l’aria. Allentò subito la cravatta e aprì il primo bottone della camicia.
Richter fece una smorfia. “Ma cosa significano allora quei graffiti? Perché quel figlio di puttana dovrebbe tradirsi così? Per permetterci di andare alla polizia?”
“Sa benissimo che non possiamo farlo,” rispose lui.
Richter rimase in silenzio per un breve istante, poi annuì.
La conversazione era conclusa.
Negli ultimi duecento metri di tragitto, Klinke non fece altro che guardarsi intorno, ma, per quanto scrutasse, nulla suggeriva che qualcuno li avesse seguiti.
Richter fece scendere il passeggero davanti a casa sua. Il medico saltò giù dal calesse e tagliò attraverso l’orto; alle sue spalle sentì il veicolo proseguire sferragliando.
Quasi nello stesso istante la coltre di nubi si aprì e Klinke rimase abbagliato dai raggi vivaci del sole di mezzogiorno. Prese le chiavi con un gesto abituale, e quando i suoi occhi si abituarono alla luce rimase impietrito. All’inizio riuscì a distinguere solo poche linee sottili sulla porta, guardando più da vicino, però, si rese conto che erano graffi. Sembravano casuali, ma non appena si accovacciò per esaminarli riconobbe la figura che aveva visto sulle altre tre case.
Le linee raffiguravano una sagoma umana. In corrispondenza delle spalle alcuni solchi tracciavano due forme semicircolari. Questa volta lo sconosciuto era riuscito a portare a termine con cura il suo lavoro e Klinke capì che si trattava di ali.
Rabbrividì a quella vista. L’assassino aveva marchiato la porta di casa sua. Gli era alle calcagna. Il suo tempo era scaduto, si era illuso troppo a lungo. Tutto a un tratto si sentì inerme, completamente incapace di proteggersi.
Se la diede a gambe. Più incespicando che correndo, inseguì il calesse che si allontanava, agitando le braccia e gridando a Richter di aspettarlo con tutto il fiato che aveva in corpo.
Quello si voltò perplesso e si fermò.
Klinke si appoggiò ansimante al bordo di legno del calesse.
“Dobbiamo dire subito la verità a tutti,” disse boccheggiando. “Il prossimo sono io! Dobbiamo andarcene da qui. Immediatamente!”
1
Berlino
Lunedì 9 dicembre 1946
“Ecco qui altri nomi che cominciano per L!” annunciò la signora Scholz posando una pila di schede di cartoncino sulla scrivania di Oppenheimer. Portava i capelli castano scuro legati nella solita crocchia, così alta che l’ex commissario aveva sempre timore di vederla crollare per via della forza di gravità. Lei sbatté le palpebre con fare entusiasta dietro le lenti degli occhiali, come se si aspettasse un encomio per avergli scaricato addosso tutto quel lavoro aggiuntivo.
“Ehm, sì, grazie mille,” mormorò Oppenheimer, osservandola distrattamente mentre si allontanava tra le file di scrivanie. Poi spostò l’attenzione sul suo nuovo compito. L’altezza della pila di schede gli permetteva di valutare con relativa precisione quanto tempo avrebbe impiegato a esaminarle. Preventivò circa tre ore, e a quel pensiero inspirò profondamente. La guerra era finita ormai da un anno e mezzo, ma nello stanzone comune che ospitava le scrivanie degli impiegati regnava sempre un odore di cemento e polvere.
Il flusso di richieste non accennava a smettere, ma non c’era da meravigliarsi, considerando che circa un tedesco su quattro risultava disperso, o aveva un parente che lo era. La pioggia di bombe aveva provocato la fuga di un numero incalcolabile di cittadini nei villaggi circostanti, e quando quella gente era tornata aveva trovato case e appartamenti distrutti. Alla fine della guerra, più di dieci milioni di soldati della Wehrmacht e di membri delle SS erano nei campi di prigionia; i rilasci erano cominciati già a metà maggio del 1945, ma la maggior parte di quegli uomini era ancora internata, oppure era scomparsa.
Per finire c’erano circa quattordici milioni di persone che erano fuggite verso ovest dagli ex territori orientali tedeschi, o erano state costrette ad andarsene, e adesso non avevano più una patria. I nazisti avevano ribattezzato Volksdeutsche, la popolazione di lingua tedesca che viveva fuori dai confini, per distinguerli nettamente dai tedeschi del Reich. Ora nel gergo ufficiale i profughi dell’Est venivano perlopiù definiti semplicemente “persone trasferite”.
Già nel corso della prima conferenza degli Alleati, che aveva avuto luogo a Teheran nel novembre del 1943, Roosevelt, Churchill e Stalin avevano stabilito che dopo l’ormai prevedibile fine della guerra il confine orientale sovietico-polacco dovesse correre lungo la linea Curzon. Allo stato polacco, come compensazione per le aree cedute alla Russia, era stato promesso un ampliamento del confine occidentale. Almeno sulla carta sembrava una soluzione semplice, ma non era che l’inizio di una serie di problemi. La popolazione dei territori occidentali interessati da questi provvedimenti presentava infatti una forte mescolanza di etnie, per la maggior parte non polacche. Contemporaneamente bisognava fare spazio alle famiglie polacche dei territori orientali, le quali dovevano spostarsi più a occidente.
E così un tratto di penna aveva dato vita a una migrazione di popoli di proporzioni inaudite, con una soluzione tecnocratica di cui nessuno si era curato di verificare la fattibilità. Alla conferenza di Potsdam era stato deciso che il trasferimento dovesse essere attuato “in maniera ordinata e umana”, ma negli ultimi mesi Oppenheimer era venuto più volte a sapere che la realtà era ben lontana da quell’ampollosa dichiarazione d’intenti. Le deportazioni procedevano in maniera caotica, e fin troppo spesso c’erano stati episodi di violenza gratuita.
Tutti quei destini approdavano infine sulla scrivania di Oppenheimer, che da circa sei mesi lavorava all’Ufficio Ricerche del settore americano di Berlino, la cui sede si trovava nel quartiere di Dahlem.
Dopo la breve interruzione della signora Scholz del reparto posta, Oppenheimer tornò a concentrarsi sulle schede delle persone da cercare, sfregandosi le mani irrigidite dal freddo. Per fortuna Lisa gli aveva trovato chissà dove dei mezzi guanti, grazie ai quali riusciva a esaminare le schede senza farsele scivolare continuamente dalle mani.
Sia Oppenheimer sia i suoi colleghi lavoravano indossando cappotto e guanti, perché negli ultimi giorni a Berlino era tornato il freddo. L’arrivo repentino dell’inverno, a novembre, era stato relativamente sopportabile, anche perché aveva lasciato comunque spazio a qualche giornata più mite. Da allora però il freddo si era annidato ostinatamente negli angoli dello stanzone dove tutti i giorni si sedeva alla scrivania. Il soffitto era alto sei metri, il che rendeva il locale impossibile da riscaldare, soprattutto adesso che in tutta Berlino il combustibile scarseggiava.
Oppenheimer smise di sfregarsi le mani e proseguì a esaminare le schede. Certi giorni si sentiva come un’ape operaia, ma la cosa non lo disturbava. Era facile essere semplicemente uno dei circa cinquanta impiegati seduti dietro le grandi scrivanie di legno per conto della Croce Rossa, della Caritas o della comunità evangelica di Berlino, intenti a catalogare i destini di tutta quella gente, ritrovare dispersi e riunire famiglie. In quella massa, non saltava più all’occhio. Lavorava chino sulla scrivania per otto ore al giorno, adeguandosi alla routine.
Da commissario avrebbe rischiato tutti i giorni di finire sotto il fuoco incrociato degli Alleati, che raramente si trovavano d’accordo su qualcosa, perciò preferiva di gran lunga occuparsi di scartoffie. I nomi delle persone erano quelli e basta. E non avevano un significato politico.
Lang, Lange, Längefeld, Langenbach, Lagemack, Langenberg. Oppenheimer dovette socchiudere gli occhi per decifrare ciò che c’era scritto sulle schede. Nonostante i finestroni alti fino al soffitto su entrambi i lati dello stanzone, il cupo cielo invernale non lasciava passare abbastanza luce e le lampade, ordinatamente disposte su tre file sopra gli impiegati, per il momento avevano solo una funzione decorativa, perché dall’inizio di novembre l’amministrazione cittadina aveva imposto il blocco della corrente elettrica. Lui temeva che anche quell’anno si profilasse all’orizzonte la stessa catastrofe degli approvvigionamenti che aveva caratterizzato il primo inverno del dopoguerra. Anche allora era stato imposto un severo razionamento della corrente, perché non c’era carbone sufficiente per rifornire le centrali elettriche.
Il problema si era ulteriormente aggravato, perché l’amministrazione militare sovietica aveva dichiarato di non essere in grado di garantire l’approvvigionamento di tutta Berlino con le risorse delle zone circostanti. Ciascuna delle potenze occupanti aveva quindi dovuto provvedere autonomamente a rifornire di cibo e materie prime il proprio settore. Al momento quindi, i settori britannico, francese e americano venivano approvvigionati dall’ovest sfruttando un unico binario. Nonostante tutto, Oppenheimer cercava di guardare al lato positivo: se l’inverno alla fine si fosse abbattuto su di loro, lui almeno aveva un paio di guanti caldi.
Prese una dozzina di schede e le smistò, poi si chinò in avanti per archiviarle negli scomparti di legno sotto la ribalta mobile della sua scrivania. Era così concentrato sul suo lavoro che non si accorse dei passi rapidi dietro di lui. Solo quando percepì qualcuno che si chinava sopra la sua spalla si rese conto che era successo qualcosa.
“Signor Oppenheimer, una visita per lei,” gracchiò una voce.
Era il signor Furmannek, il quale si sforzava sempre di presentarsi con abbigliamento e modi impeccabili, per evitare che la benda nera che portava sull’occhio lo facesse assomigliare a un pirata. Il cappotto completamente abbottonato non lasciava vedere molto, ma Oppenheimer non dubitava che il suo collega indossasse come al solito una camicia dal colletto rigido e una cravatta ben annodata.
“Ma come?” chiese l’ex commissario. “Non posso mica andarmene così, manca ancora un’ora alla pausa pranzo.”
A quel punto notò che Furmannek aveva il fiato corto. “Sembra urgente. Dev’essere accaduto qualcosa, c’entra una signora che si chiama Hilde. Il nome le dice niente?”
Oppenheimer si alzò immediatamente. Adesso era lui a essere nervoso.
“Sì. Cosa è successo?”
Il collega scosse il capo e indicò il reparto posta. Oppenheimer mise rapidamente da parte le schede e si fece strada tra le scrivanie.
Nell’ufficio regnava un clima che pareva più appropriato a una sala da tè. Una mezza dozzina di donne era seduta davanti a una montagna di carte, le nuove richieste di ricerca, che le signore smistavano mentre chiacchieravano allegramente. Accanto a loro c’era una figura grigia e baffuta, che teneva il cappello tra le mani con aria impacciata.
Era Otto Seibold. Oppenheimer lo vide raddrizzarsi gli occhiali e agitare i baffi per il nervosismo, con il viso paonazzo. Non ricordava di averlo mai visto così disperato nemmeno quando avevano lottato insieme a Franz Schmude per salvare la sua buona amica Hilde, fiera oppositrice dei nazisti, dalle grinfie del Tribunale del Popolo.
Quando finalmente scorse Oppenheimer, Seibold tirò un sospiro di sollievo.
“Richard, che fortuna!” esclamò così ad alta voce da farsi notare anche dalle signore sedute dietro la montagna di carte. Oppenheimer notò i loro sguardi curiosi e trascinò Seibold nel corridoio.
“Che c’è, Otto?” gli chiese. “È successo qualcosa a Hilde?”
Seibold aprì la bocca, ma non trovò subito le parole. “Non lo so,” rispose infine con un altro sospiro. “È stata fermata dal Sozialamt di Schöneberg e ha mandato una persona ad avvertirmi. Non vogliono lasciarla andare. Lei dice che solo tu puoi tirarla fuori da lì.”
Seibold aveva snocciolato tutte quelle informazioni così velocemente da rendere piuttosto faticoso a Oppenheimer seguire il filo del discorso.
“Il Sozialamt?” ripeté stupito. “Che cosa ha combinato? E perché la trattengono lì? Ha forse insultato qualcuno?”
Seibold alzò le mani in un gesto di scuse. “Non so altro. Ma è meglio che tu vada subito.”
Se una persona in gamba come Hilde non riusciva a tirarsi fuori d’impaccio, voleva dire che la situazione era davvero grave. Preoccupatissimo, Oppenheimer avrebbe voluto precipitarsi subito in strada, ma non appena posò la mano sulla maniglia, qualcosa lo trattenne. Abbandonare in quel modo il posto di lavoro non gli piaceva.
“Così non va bene,” mormorò. “Devo prima avvisare.” Sparire nel nulla poteva dare un’impressione sbagliata. Durante i mesi estivi era capitato che parecchi colleghi risultassero assenti. In particolare il venerdì e il sabato salivano a bordo di treni stracolmi chiamati “gli espressi delle calorie” e affrontavano il faticoso viaggio verso le campagne per barattare un po’ di cibo. Ovviamente quei viaggi di accaparramento erano illegali, a meno che non si avesse una tessera, ma da quando si era sparsa la voce che la polizia chiudeva un occhio, le banchine dei treni erano diventate sempre più affollate.
I medici nutrizionisti avevano calcolato che un adulto che lavorava aveva un fabbisogno quotidiano di 2.200 calorie, ma a causa della disperata situazione degli approvvigionamenti l’amministrazione cittadina aveva progressivamente ridotto gli alimenti ottenibili con la tessera annonaria, per cui i berlinesi ricevevano soltanto la metà delle calorie necessarie. Nei negozi c’erano praticamente solo pane e patate, nel settore russo al posto delle razioni di carne spesso venivano distribuite aringhe o formaggio. Verdure fresche non ce n’erano quasi mai, così come la razione di grassi prevista.
La scarsità di cibo metteva tutti di fronte a una difficile decisione. Aveva senso presentarsi al lavoro per avere diritto a una tessera, nell’incerta speranza che nei negozi ci fosse qualcosa da comprare? Non era meglio investire un paio di giorni per andare ad accaparrarsi del cibo in campagna?
Adesso tuttavia, con l’arrivo dei primi freddi invernali e visto che i contadini non avevano più molto da offrire, il numero degli assenti si era notevolmente ridotto, perciò Oppenheimer ritenne di avere buone possibilità di ottenere un paio d’ore di permesso. In fondo poi, poteva sempre sostenere che si trattasse di una trasferta di lavoro. Si voltò e tornò in ufficio.
“Vieni, Otto,” gli disse in fretta. “Devi raccontare al signor Suhr quello che hai appena detto a me.”
“E chi è questo signor Suhr?” chiese Seibold.
“Il mio superiore.”
Ma perché si era lasciato coinvolgere? E perché era venuto lì? Georg Hüttner fissava il tappeto scolorito. Era nervoso, come sempre quando si trovava nel settore americano. Sebbene solo pochi chilometri lo separassero dalla zona sovietica, si ripromise di restare all’erta. Un passo falso nel territorio degli imperialisti occidentali poteva avere conseguenze disastrose. Di solito quando si recava lì cercava di farlo insieme a un altro compagno. Era meglio così, per non destare il sospetto di essere in combutta con le potenze capitaliste.
Hüttner tuttavia custodiva segreti che non dovevano affiorare alla luce del sole, perciò quella mattina non aveva avuto altra scelta che avventurarsi nella tana del leone senza accompagnatore.
Ma rimpiangeva quella decisione.
“Ti va un tè?”
L’innocente domanda di suo fratello Josef strappò Hüttner dai suoi cupi pensieri. Curvò le labbra in un sorriso e annuì, sebbene con un po’ di amaro in bocca. Avrebbe dovuto pensare a portare pure del tè, anche se ora gli veniva generosamente offerto. Oltre alla carne in scatola, allo zucchero e alle patate, Hüttner aveva portato dei fiammiferi e un po’ di legna da ardere.
Avrebbe voluto andarsene subito, ma non gli era parso saggio squagliarsela così. Era dolorosamente consapevole di quanto Josef lo tenesse in pugno, perciò, controvoglia, aveva fatto buon viso a cattivo gioco. E il gioco in quel caso aveva un nome ben preciso: ricatto. Era di certo meglio comportarsi come se fosse andato lì per una semplice visita e perdere qualche minuto per dare a Josef un’impressione di normalità. Hüttner tentò quindi di mettersi comodo sulla poltrona logora, impresa non facile visto che sentiva distintamente ogni singola molla.
Josef andò nel cucinino scarsamente ammobiliato, come del resto tutta la casa. C’era una stufa piastrellata, con un lungo tubo che provvedeva anche al riscaldamento, e un lavandino di metallo fissato con due viti alla parete, con lo smalto scrostato in diversi punti. In mezzo alla stanza c’era un’enorme tinozza, che serviva principalmente a raccogliere l’acqua che gocciolava dal soffitto.
Almeno però quella mansarda era decisamente più grande degli altri appartamenti, aveva persino un ingresso separato e un gabinetto privato. Probabilmente era già un gran lusso.
Hüttner scrutò attentamente suo fratello. Ma era da sciocchi, e non poteva essere altrimenti, cercare dei tratti effeminati nell’atteggiamento di Josef, una nota appariscente nella sua voce, di cui lui stesso non si rendeva conto, o un movimento sconveniente dei fianchi.
Hüttner stava ancora osservando la figura impacciata di Josef davanti ai fornelli, quando un soffio di vento gelido entrato dalla finestra gli solleticò la nuca. Faceva più freddo lassù, come aveva immaginato. Pensò che era stato un errore togliersi il cappotto e fece per tornare nell’ingresso, dove l’aveva appeso.
Davanti alla porta si bloccò. Gli pareva di aver sentito un rumore. Forse c’era qualcuno. Che magari stava origliando.
Spalancò la porta ed entrò nell’ingresso. Ma non c’era nessuno. L’unica sagoma era quella del suo cappotto grigio appeso a un gancio.
Sbuffò sollevato. Probabilmente i suoi sensi gli avevano giocato un brutto tiro. Adesso vedeva persino i fantasmi. Non poteva che essere così. Si avvolse nel cappotto caldo e tornò alla poltrona.
“Non era niente,” disse scuotendo la testa quando notò lo sguardo interrogativo di Josef. Si lasciò cadere sulla poltrona e scrutò con occhi cupi il tavolo di legno, sul quale era posato il pacchetto che conteneva i generi alimentari avvolti in carta oleata.
Sebbene avesse poco a che vedere con quella faccenda, Hüttner era al corrente dello stato di bisogno della popolazione di Berlino: la fame dilagante, contro la quale persino le massicce importazioni di cereali dall’estero erano state solo una goccia nel mare; e la mancanza di combustibile, che aveva costretto i berlinesi a sradicare cespugli e alberi nei parchi e a derubare i convogli del carbone…
Berlino era molto diversa da come la ricordava. Ma forse la verità era che nei lunghi anni del suo esilio l’aveva sempre idealizzata. Aveva ripreso il suo vecchio nome, ma ancora non si era abituato al fatto che la gente non lo chiamasse più con il suo soprannome russo: Jurka.
Si sentiva uno straniero nella sua stessa città. Non l’aveva messo in conto quando, pochi mesi prima della fine della guerra, era stato portato lì insieme a una manciata di altri esuli tedeschi, con un turbolento volo diretto Mosca-Berlino. Da lontano la situazione della città non gli era parsa poi così difficile. In Russia il suo lavoro l’aveva tenuto impegnato tutti i giorni. Scriveva testi per l’emittente radio Freies Deutschland, per diffondere le voci contrarie alla propaganda nazista e affermare il potere della parola contro la tirannia. Ma tutta la sua formazione politica non era stata sufficiente a prepararlo alla complessa e inedita situazione che si era trovato di fronte al suo ritorno.
Stalin stava collaborando con gli Alleati occidentali, sebbene – fatta eccezione per il comune nemico fascista – fosse in pieno disaccordo con loro dal punto di vista ideologico. Inoltre, la vista del cumulo di macerie in cui Berlino si era trasformata lo aveva lasciato sbalordito. Lo sgomento si era accresciuto quando aveva saputo dei crimini di cui si erano macchiati i soldati dell’Armata Rossa. All’inizio era convinto che la gente mentisse, i compagni di Hüttner si accontentavano della spiegazione semplicistica secondo cui i resoconti degli stupri e dei saccheggi erano soltanto propaganda diffusa dai fascisti per sabotare la loro opera di ricostruzione. Del resto le truppe russe avevano combattuto per una giusta causa, perciò era impossibile che quei racconti fossero veri.
Ma nei mesi seguenti, man mano che le notizie giungevano alle sue orecchie, la sua incertezza rispetto a quale fosse la realtà dei fatti era cresciuta. La via per la liberazione, del resto, non era quasi mai una passeggiata. In ogni caso, visto che si era impegnato a costruire un futuro migliore, era suo compito dare un senso a quei terribili avvenimenti.
Ci volle un po’ prima che l’acqua per il tè bollisse. O almeno a Hüttner parve che fosse trascorsa un’eternità quando finalmente Josef gli posò davanti una tazza piena di liquido fumante. Poi si accomodò di fronte a lui sul letto, l’unico altro posto su cui era possibile sedersi in quell’appartamento.
“Non volevo farlo,” tentò infine di giustificarsi Josef, avvolgendosi meglio intorno al corpo il cappotto troppo grande. “Ma devo pur vivere in qualche modo. Lo capisci?”
“Adesso non importa,” borbottò Hüttner. Non aveva sete, ma sorseggiò lo stesso il tè, almeno la tazza gli scaldava un po’ le mani. Si tirò su il bavero del cappotto. Odiava il freddo, e gli anni in esilio gli avevano insegnato che anche la maggior parte dei russi era della sua opinione. All’inizio pensava che le temperature artiche non dessero loro alcun fastidio, come se avessero un fuoco interno che li teneva sempre al caldo. Ancora non si capacitava di quanto fosse stato ingenuo.
“Quella roba…” disse Josef. “Segnati tutto ciò che mi porti. Prima o poi ti ripagherò.”
Hüttner ridacchiò tra sé e sé. Non credeva affatto che suo fratello avrebbe mai ripagato i suoi debiti.
“Non posso venire regolarmente a portarti qualcosa,” precisò Hüttner. “Incontrarci in questo appartamento è piuttosto rischioso per me.”
“Potresti propormi di vederci da qualche parte nel settore russo.”
Hüttner rifletté su quell’offerta. Di certo avrebbe semplificato le cose, ma allo stesso tempo aumentava il rischio che qualche compagno lo vedesse. Se quella faccenda per caso fosse venuta fuori, potevano esserci delle complicazioni.
Pensò in fretta a una risposta evasiva, ma non ebbe il tempo di pronunciarla ad alta voce perché tutto a un tratto da fuori si sentì un gran fracasso.
Prima si udirono delle sirene in lontananza, poi si aggiunse il rombo dei motori. E infine nell’appartamento risuonarono delle voci concitate.
Hüttner spalancò gli occhi. I suoi peggiori timori si erano rivelati veri. Balzò in piedi e con due passi rapidi raggiunse la finestra. Uno dei vetri si era rotto ed era stato sostituito da un pezzo di cartone, ma tendendo il collo si riusciva a vedere la strada.
Due auto della polizia spuntarono all’improvviso e frenarono davanti alla casa.
Hüttner si sentì colto con le mani nel sacco. Di colpo il suo incontro segreto con Josef gli apparve sotto una luce completamente diversa. Era stato solo uno stratagemma per attirarlo nel settore americano? Forse suo fratello non voleva ricattarlo, no, la vera motivazione era la vendetta. Non riusciva a trovare un’altra spiegazione.
“Maledetto bastardo,” sibilò. Poi prese il cappello.
“Non per le scale!” gli gridò dietro Josef, ma lui non ascoltò l’avvertimento.
In un istante uscì sul corridoio buio e guardò giù dalla ringhiera.
Qualcuno stava bussando al portone d’ingresso.
Era all’ultimo piano. L’unica, minuscola possibilità di scappare dal cortile posteriore implicava scendere fino in fondo alle scale.
Come dotati di vita propria, i suoi piedi volarono giù per i gradini. Al piano terra andò a sbattere contro un’anziana signora che stava andando ad aprire il portone principale.
“Ehi, stia un po’ più attento,” gli gridò dietro irritata.
Da fuori continuavano a bussare.
Hüttner percorse un angusto corridoio sul retro dell’edificio. Ancora pochi passi e avrebbe raggiunto l’ingresso posteriore.
Tese la mano e abbassò la maniglia. Stava per precipitarsi fuori, ma si bloccò. Non sapeva cosa lo attendesse dall’altra parte. Se era sfortunato, nel cortile avrebbe trovato la polizia ad aspettarlo.
Aprì con cautela la porta, creando una piccola fessura da cui sbirciare. Fu accolto dall’odore di fumo. Qualcosa nel vicinato stava andando a fuoco, ma davanti alle macerie accatastate dietro le case vide solo una distesa di bidoni dell’immondizia e di panni stesi. Spalancò la porta e uscì.
Con il cappello calcato sulla fronte, si allontanò dal muro. Cercava di non dare nell’occhio, ma era evidente che stesse aumentando progressivamente il passo. Se fosse riuscito a raggiungere le macerie del palazzo di fronte sarebbe stato salvo.
Ansimante, si affrettò ad attraversare il cortile interno, ma tutto a un tratto alle sue spalle qualcuno gridò: “Fermo! Polizia!”
Lui non si voltò, era quasi arrivato alle macerie. Altri due passi e sarebbe sparito nell’edificio distrutto. Mantenne lo sguardo fisso davanti a sé, senza più badare a dove metteva i piedi.
Non aveva però messo in conto che ci fosse qualcos’altro in quel cortile. Un elemento estraneo, che aveva ancora meno ragioni di lui di trovarsi in quel posto.
All’inizio percepì solo qualcosa che faceva resistenza contro il suo piede destro. Perse l’equilibrio, crollò pesantemente a terra e sentì un dolore lancinante al ginocchio. Il terreno disseminato di sassi e schegge di vetro gli scorticò le mani.
In un attimo sentì dei passi avvicinarsi, qualcuno lo afferrò per le braccia e lo tirò in piedi. Hüttner agitò le gambe finché non sentì di nuovo il terreno solido sotto di lui.
I suoi due aggressori portavano il berretto delle forze di polizia di Berlino. Uno di loro gli premeva un manganello di legno contro la nuca. Ma proprio nel momento in cui l’avevano finalmente in pugno, improvvisamente non si curarono più di lui. Qualcos’altro aveva attirato la loro attenzione.
“Merda,” esclamò uno dei poliziotti.
I due tutori dell’ordine pubblico stavano guardando l’ostacolo sul quale Hüttner era inciampato. All’inizio neanche lui riuscì a dargli un senso, era uno spettacolo troppo inconsueto ed enigmatico.
Sul terreno grigiastro, tra i bidoni dei rifiuti, spuntava un braccio. La pelle nuda era ricoperta di scritte, ma Hüttner era troppo lontano per poterle decifrare. Il cadavere giaceva contorto tra i secchi dell’immondizia. Aveva i capelli grigi, e la bocca spalancata era color carbone. Invece di un grido, dalle sue labbra parve uscire l’ultimo sbuffo di fumo denso di un incendio morente.
Aveva già intuito che la situazione si era fatta pericolosa per lui, adesso però il rischio era diventato mortale. La polizia l’aveva sorpreso nei pressi del cadavere nudo di un uomo. E nel settore americano, dove lui non poteva spiegare cosa era venuto a fare.
A poco a poco si rese inequivocabilmente conto di non poter giustificare in alcun modo la sua presenza. Non poteva nemmeno addurre testimoni a sua discolpa. Quel pensiero gli serrò la gola.
2
Lunedì 9 dicembre 1946
Oppenheimer strinse le palpebre. Le gocce di pioggia continuavano a cadergli sulla faccia. Voleva arrivare da Hilde il prima possibile. Spinse con forza sui pedali, che a ogni giro emettevano un cigolio penetrante. La bicicletta era ancora il mezzo migliore per spostarsi in città. Aveva riparato così tante volte quel veicolo inservibile che aveva raccolto dal ciglio della strada poco dopo l’occupazione di Berlino, che ormai davvero non sapeva se ci fossero ancora dei pezzi della struttura originaria.
Un gruppetto di bambini gli si fece incontro dal marciapiede. Ridevano allegramente, mentre facevano rotolare davanti a loro dei pesanti pneumatici di gomma. Oppenheimer si chiese dove avessero trovato quei preziosi oggetti, poi dopo qualche centinaio di metri vide sul marciapiede un veicolo sollevato con il cric. Evidentemente i passanti avevano colto l’opportunità al volo e avevano letteralmente smontato l’auto lasciata incustodita per ricavarne pezzi di ricambio. Oppenheimer era molto irritato dal dilagare di comportamenti vandalici di quel genere. Aveva notato i primi segnali di decadenza morale già negli ultimi anni di guerra. Se qualcuno aveva bisogno di qualcosa che non poteva ottenere per vie legali, non si vergognava di rubarla. A Berlino non c’era pensione in cui gli ospiti non avessero svitato persino le lampadine dai loro supporti.
A volte aveva l’impressione di trovarsi in una specie di mondo parallelo, in cui non esistevano più regole. A parte i bambini che giocavano, per la città capitava sempre più spesso di vedere figure che si aggiravano a capo chino in un paesaggio fatto di macerie. “Ruderi umani”, così si definivano talvolta loro stessi. Quegli involontari cavernicoli dell’era moderna portavano sulle spalle un peso invisibile. Per la prima volta dalla fine della guerra tra di loro si era diffusa una sensazione di generale avvilimento. La dura verità era che la Germania non esisteva più come Stato. L’ex nazione era stata suddivisa in settori, non aveva più una bandiera, né un inno nazionale ufficiale. I pochi complessi industriali che non erano stati dismessi avevano difficoltà a trovare fornitori, perciò finora nel paese si produceva ben poco. Almeno Berlino aveva di nuovo un’amministrazione comunale democraticamente eletta dai cittadini, che si era insediata appena quattro giorni prima. Ma per il momento i destini di tutti rimanevano in mano agli Alleati.
Oppenheimer non riusciva a capire perché la popolazione tedesca non provasse entusiasmo per la fine della guerra. Persino in coloro che durante i lunghi anni di oppressione avevano anelato alla liberazione dal nazionalsocialismo non vedeva un grande ottimismo. Forse parte di loro percepiva comunque la disfatta militare come un’umiliazione.
Dopo l’agitazione iniziale, il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che lo aveva turbato profondamente, era caduto presto nel dimenticatoio. La stampa controllata dagli Alleati aveva trattato la faccenda con toni molto discreti. La mostruosa forza distruttiva del nuovo tipo di bomba era stata presentata convenientemente, sottolineando l’affascinante dettaglio per cui la nuova arma si basava su un’energia analoga a quella del sole. Inoltre tutti avevano saputo che in origine la bomba atomica non era stata sviluppata con l’obiettivo di porre fine alla guerra nel Pacifico, ma per essere usata contro la Germania. Gran parte della popolazione si era sentita sollevata di averla scampata ancora una volta, la tempestiva disfatta dell’esercito hitleriano aveva evitato al paese una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.
L’unica vittima era stato il Giappone, ma a Berlino pochissimi badavano a cosa accadeva all’estero. La maggior parte non si interessava nemmeno a cosa capitava nei quartieri vicini e si occupava soltanto di ciò che aveva a che fare con la propria quotidianità. Il che voleva dire soprattutto cercare di capire in che misura Est e Ovest andassero d’accordo.
L’autorità suprema a Berlino aveva preso la significativa denominazione di Allied Kommandantura, e già quel nome composto da una parola inglese e una russa sembrava indicare quanto mal si accordassero i partner dell’alleanza. Difatti la loro cooperazione filava tutt’altro che liscia. L’amministrazione militare sovietica si rifiutava categoricamente di porre sotto un controllo comune l’università di Berlino, che aveva sede nel suo settore, e allo stesso tempo non era disposta a concedere alla Allied Kommandantura la supervisione della Haus des Rundfunks, il principale centro radiofonico della città che i sovietici avevano occupato negli ultimi giorni di guerra, e che era poi ironicamente finito nel settore britannico. Britannici e americani avevano perciò messo in funzione una propria emittente radio in lingua tedesca, per offrire ai berlinesi una voce alternativa da opporre alla dominante presenza radiofonica sovietica.
Oppenheimer vide un negozio davanti al quale stazionava una lunga fila di persone. Di tutta la costruzione era rimasta in piedi solo la facciata, sulla quale qualcuno aveva scritto con la vernice bianca un’amara constatazione: “Ecco i risultati della guerra”. L’edificio distrutto troneggiava sopra una montagna di detriti, ma un commerciante intraprendente aveva sgombrato il piano terra quel tanto che bastava per mettere in vendita la merce.
“Proprio un bel disastro!” si lamentava una donna anziana con un fazzolettone in testa. Per rendere più gradevole l’attesa si era seduta su una malconcia tazza da gabinetto, che presumibilmente aveva trovato da qualche parte tra le rovine.
Per un breve istante Oppenheimer riuscì a intravedere il proprietario del negozio, che era andato ad aprire la porta a una cliente. Nonostante il grembiule lindo e pulito, era evidente che non avesse merce a sufficienza per soddisfare le necessità della sua clientela. In vetrina erano esposte cianfrusaglie da poco, oppure articoli di lusso scandalosamente cari, che nessuno poteva permettersi. La merce veramente importante per la vita di tutti i giorni veniva chiaramente spacciata sottobanco.
La signora elegante che era appena uscita dal negozio indossava costose calze di nylon. Mentre incedeva sui tacchi percorrendo a ritroso la fila dei clienti in attesa, attirò su di sé non pochi sguardi di invidia.
“E lei questa la chiama democrazia?” le gridò dietro la donna con il fazzolettone in testa, al colmo dell’irritazione.
La nuova struttura ufficiale dello Stato era diventata in men che non si dica una sorta di insulto, e ovviamente ciascun settore pensava che la propria potenza occupante fosse la peggiore di tutte. Lì a Schöneberg la gente si lamentava degli americani, gli abitanti di Charlottenburg e Wilmersdorf dicevano peste e corna dei britannici, mentre a nord, nei quartieri di Wedding e Reinickendorf, si deplorava il comportamento dei francesi. Andava poi da sé che nella parte est della città, per esempio a Lichtenberg e a Friedrichshain, i residenti avessero parecchio da ridire sui russi.
Per qualche assurdo motivo, inoltre, gli ex collaboratori del regime nazista che erano stati smascherati si consideravano vittime di Hitler, perché non ricoprivano più le alte cariche di una volta ed erano stati obbligati a contribuire allo sgombero delle macerie dalla città. In quanto addetti ai lavori pesanti ricevevano razioni di cibo migliori di quelle che avrebbero ottenuto con i loro vecchi impieghi, ma di norma sorvolavano intenzionalmente su quel particolare.
Oppenheimer aveva visto fin troppi concittadini calarsi con estrema presunzione in quel nuovo ruolo di vittime, e ne era profondamente irritato.
Quando Potsdamer Straße diventò Hauptstraße, era quasi arrivato. In lontananza distingueva già la torre tonda della Paul Gerhardt Kirche, che gli ricordava una cisterna, e in effetti poco dopo, sulla facciata di una filiale della Dresdner Bank, vide uno striscione agitato dal vento sul quale era scritto in lettere bianche “Municipio di Schöneberg”. Il municipio originario era stato gravemente danneggiato, perciò quella era diventata la sede provvisoria dell’amministrazione cittadina.
L’ex commissario frenò e scese dalla bici, dopodiché camminò lungo un lato del filo spinato fino all’ingresso principale e cominciò a leggere le targhette sulle porte, sperando di imbattersi in quella del Sozialamt. Quando si affacciò su un corridoio vide finalmente Hilde, ferma davanti a una porta insieme a una buona dozzina di altre persone. In mezzo a quelle figure grigie saltava subito all’occhio. Indossava un cappello vecchio stile e una mantella impermeabile che aveva visto giorni migliori. Con quegli abiti sembrava quasi una matrona, se non fosse stato per i capelli ondulati che spuntavano da sotto la falda del cappello. Quando si accorse di Oppenheimer aggrottò la fronte.
“Eccoti finalmente!” esclamò in tono di rimprovero. “Accidenti a te, sono ore che aspetto qui in piedi!”
Lui aveva ancora il fiato corto. “Ma cosa è successo?” chiese preoccupato.
Invece di rispondergli, Hilde gli ficcò in mano un pezzo di carta. “Ecco qua! Io non ne posso più. Adesso fai domanda per il certificato di vittima del fascismo, e non voglio sentire una parola!”
Per un attimo Oppenheimer rimase a bocca aperta, senza capire. Poi si rese conto di essere caduto in un tranello.
“È per questo che hai disturbato Otto?” chiese indignato. “Solo per costringermi a fare la domanda per quello stupido certificato?”
“Non è affatto stupido,” ribatté lei. “Piantala di giocare al nobile eroe, ti spetta di diritto, e sarebbe da stupidi rinunciarci!”
Oppenheimer inspirò profondamente. “Tanto non si trova granché da mangiare neanche con la tessera,” mormorò.
“Non importa,” lo rimbrottò Hilde. “In ogni caso con quel certificato avresti diritto a razioni maggiori.”
Subito dopo la guerra in tutte e quattro le zone d’occupazione era stato fondato un comitato per le vittime del fascismo, che doveva provvedere alle necessità delle persone che sotto il regime nazionalsocialista erano state perseguitate per la loro fede politica. Oltre a razioni migliori, il certificato garantiva anche altri vantaggi, tra cui per esempio l’assistenza medica e una distribuzione speciale di abiti e scarpe. Talvolta il comitato trovava addirittura un alloggio per le vittime di Hitler.
Non era però un segreto che a fare domanda per il certificato fossero spesso persone che non erano state affatto vittime, e tantomeno oppositori, del nazismo. I richiedenti venivano quindi controllati scrupolosamente e suddivisi in diverse categorie e sottogruppi, ma a eccezione degli impiegati che se ne occupavano, nessuno sapeva quali fossero i criteri di classificazione.
“Adesso entri lì e lo fai, ho già compilato tutto,” proseguì Hilde. “Ci vuole un sacco di tempo prima che la richiesta venga esaminata.”
Nonostante le esortazioni della sua amica, Oppenheimer rimase immobile accanto alla bicicletta, come se avesse piantato radici lì. Gli uomini in attesa davanti all’ufficio certificati gli lanciarono degli sguardi perplessi. Tra di loro c’era anche un uomo che si era presentato con l’uniforme a righe di un campo di concentramento, come prova del suo status di vittima. A Oppenheimer si serrò la gola nel vederlo. Con l’introduzione dei primi provvedimenti razziali era stato sollevato dal suo incarico in polizia e costretto a tirare avanti per diversi anni in una Judenhaus, ma di fronte ai sopravvissuti dei campi si sentiva una specie di ciarlatano. Il cosiddetto matrimonio “misto” con Lisa, che era ariana, l’aveva in qualche modo protetto, ma, se non fosse entrato in clandestinità dopo la conclusione del caso Lutzow, l’ultima ondata di arresti avrebbe travolto anche lui e sarebbe stato deportato in un campo di sterminio insieme agli ultimi ebrei rimasti.
Probabilmente sarebbe andata proprio così, se non avesse ricevuto l’aiuto di diverse persone, tra cui soprattutto Hilde. Per fortuna quel terribile periodo si era concluso e lui avrebbe voluto definitivamente metterci una pietra sopra. Aveva senza dubbio un passato alle sue spalle, ma era ancora più convinto di avere un futuro davanti, per quanto nebuloso potesse sembrare.
“Io sono scampato al peggio,” protestò Oppenheimer.
Hilde non si degnò nemmeno di ribattere a quell’obiezione, gli strappò di mano il manubrio della bici e lo spinse decisa verso l’ufficio.
Oppenheimer fece una smorfia e infine si rassegnò al suo destino. Di certo Hilde voleva solo il suo bene e come sempre quando si metteva in testa una cosa, resistere era perfettamente inutile.
Bussò alla porta ed entrò.
Due ore dopo, quando tornò al suo ufficio, scoprì che quella giornata aveva ancora delle sorprese in serbo per lui. Si sentiva la coscienza così sporca per via della sua assenza, che passò davanti al reparto posta e puntò dritto alla sua scrivania senza nemmeno guardarsi intorno.
Soltanto quando scorse il suo superiore nella sala comune ebbe un moto di sorpresa. Di norma il signor Suhr non usciva mai dal suo ufficio, adesso invece era seduto su una sedia tra le file di scrivanie, con lo sguardo rivolto verso l’entrata. Era un ometto basso, sempre con il papillon e molto riservato. Quel giorno le rughe sulla sua fronte sembravano particolarmente pronunciate.
Quando vide Oppenheimer balzò in piedi e gli si avvicinò con un’espressione molto seria in volto. “Può venire con me?” mormorò.
L’ex commissario notò che alcuni colleghi bisbigliavano tra loro, con una mano davanti alla bocca.
Suhr lo guidò goffamente fuori dalla stanza e si fermò davanti alla porta dei bagni, dove si accostò a lui con fare quasi cospiratorio.
“Dunque, signor Oppenheimer, c’è una persona per lei. La sta aspettando già da un’ora.”
“Mi scusi signor Suhr, di chi sta parlando?”
“Ma di quel russo, no?” sbottò lui. “Quello con la divisa e tutto il resto. Credo sia un ufficiale.”
Oppenheimer si fermò a riflettere. Un ufficiale sovietico che spuntava fuori dal nulla nel settore americano suscitava senza dubbio un notevole scalpore. Persino lui era un po’ preoccupato. Era lì per arrestarlo? Per deportarlo in Unione Sovietica? Non era un pensiero campato in aria. Il giorno successivo alla sconcertante sconfitta della SED, il partito di unità socialista, alle elezioni per il consiglio cittadino del 20 ottobre 1946, in tutta la zona occupata e nel loro settore di Berlino le autorità sovietiche avevano avviato una vera e propria razzia di operai specializzati, esperti e scienziati tedeschi, che erano stati spediti a est verso una meta non ben definita.
Dopo qualche istante tuttavia si tranquillizzò: un ex commissario della polizia criminale di certo non era paragonabile a un operaio specializzato in qualche settore industriale chiave.
“Per caso sa come si chiama quest’uomo?” chiese al signor Suhr. “O magari le ha detto cosa vuole da me?”
“Purtroppo non sono riuscito a capire nulla,” rispose il suo superiore. “Credo che questo signore non parli una parola di tedesco, però si è accomodato per bene nel mio ufficio, in pratica me l’ha confiscato! E ha avuto anche l’inaudita sfacciataggine di posare i piedi sulla mia scrivania, con tutti gli stivali infangati!” A quel pensiero Suhr strinse i pugni.
Oppenheimer rifletté che un comportamento del genere in effetti era in grado di far infuriare persino un vecchio impiegato prussiano. Annuì rivolto al suo superiore, ma non gli venne in mente nulla che potesse placarlo.
Non appena mise piede nell’ufficio di Suhr, l’ex commissario percepì l’inconfondibile tanfo del tabacco russo machorka. Dietro la nuvola di fumo si intravedeva una sagoma in movimento, e Oppenheimer riuscì a distinguere una testa con i capelli tagliati corti che dal colletto della divisa si sporgeva verso di lui.
“Moj drug Oppenheimer!” disse l’ufficiale sorridendo e mettendo in mostra i denti incapsulati nell’acciaio scintillante.
Era il colonnello Aksakov. La sua reazione allegra e il fatto che si fosse rivolto a lui con la parola russa che significava “amico” permisero all’ex commissario di tirare il fiato. Era passato più di un anno dal loro ultimo incontro e Aksakov sembrava passarsela così bene a Berlino che il suo viso si era fatto ancora più tondo.
Il colonnello si avvicinò a Oppenheimer e lo attirò a sé. Neanche quando avevano catturato insieme il disertore Grigoriev e la sua banda ricordava di essere stato salutato in maniera così calorosa da lui. Questo significava che aveva bisogno di un favore. E infatti, senza aggiungere spiegazioni, Aksakov lo prese per un braccio e lo trascinò fuori.
Oppenheimer non ebbe neanche il tempo di congedarsi dal signor Suhr, ma di sicuro il suo capo fu felice di veder sparire l’ufficiale sovietico dal suo ufficio.
3
Lunedì 9 dicembre 1946
All’inizio a Oppenheimer parve di udire come un ronzio di api infuriate, invece erano le turbine di un aereo in fase di atterraggio che calava in picchiata sopra i tetti delle case. Dovevano essere vicinissimi all’aeroporto di Tempelhof.
Si trovava sul sedile posteriore di una grossa limousine e dallo specchietto retrovisore osservava i tratti asiatici di Serëža, l’autista di Aksakov. Il colonnello non aveva rivelato dove intendeva portarlo e in quell’onnipresente distesa di edifici e macerie bombardate era molto facile perdere il senso dell’orientamento.
Era stato calcolato da uomini d’ingegno che a Berlino ci fossero 55 milioni di metri cubi di terra e pietra, 11 milioni di metri cubi di legno e 1,3 milioni di tonnellate di acciaio. L’entità complessiva delle macerie era stata stimata intorno a circa un centinaio di milioni di tonnellate, che corrispondevano a un volume di settantacinque milioni di metri quadri. In altre parole: era possibile che i lavori di rimozione dei resti dei bombardamenti durassero fino al 1970. Altri avevano calcolato che con le macerie berlinesi si sarebbe potuto costruire un muro largo trenta metri e alto cinque che arrivava fino a Colonia.
Per quel che Oppenheimer riusciva a intuire, si stavano dirigendo verso est, ma solo quando Serëža svoltò sulla rotatoria di Belle-Alliance-Platz, che nel frattempo aveva cambiato nome in Franz-Mehring-Platz in onore di uno dei fondatori del KPD, il partito comunista tedesco, riuscì di nuovo a capire dove si trovavano.
L’autista di Aksakov rallentò. La loro meta dunque era Hermannstraße, a Neukölln. Una volta quello era stato un quartiere borghese, ma ora anche lì le strade erano grigie e i muri delle case pieni di fori di proiettile. Oppenheimer aveva dato per scontato che Aksakov l’avrebbe portato nella zona sovietica; indovinare che cosa il colonnello potesse cercare in quella americana andava oltre le sue capacità.
Serëža si fermò sul ciglio della strada con il motore acceso e scrutò i dintorni con aria diffidente. Il colonnello invece non si fece scrupoli del genere e senza dire una parola aprì la portiera e scese dall’auto.
Si avvicinò a una casa in rovina e imboccò deciso un angusto vicolo laterale, che conduceva al cortile sul retro. Sebbene fosse un buon camminatore, Oppenheimer faceva fatica a tenere il suo passo.
Una volta giunti nel cortile, Aksakov si fermò a gambe larghe davanti a un gruppetto di tre uomini in attesa, che gli lanciarono un’occhiata perplessa quando alle sue spalle videro spuntare l’ex commissario.
“Allora, che c’è?” chiese uno degli uomini. “Possiamo proseguire?”
Oppenheimer aggrottò le sopracciglia. L’uomo si tolse il cappello per asciugarsi la fronte con un fazzoletto, un’azione piuttosto difficoltosa se si considera che gli mancava il braccio sinistro.
“Billhardt?” domandò Oppenheimer.
L’uomo con il fazzoletto ebbe un sussulto. “Ci puoi scommettere,” mormorò rivolto a lui. Quindi si rimise in fretta e furia il cappello.
“Oppenheimer? Sei proprio tu?”
All’epoca in cui erano colleghi alla squadra omicidi, tra di loro si era instaurata la scherzosa abitudine di darsi del tu, ma di chiamarsi per cognome.
“Già, come vedi sono ancora in circolazione,” rispose Oppenheimer. “Sei tornato in servizio?” chiese indicando con un cenno del capo in direzione dei bidoni della spazzatura. Nonostante la sorpresa di trovare lì un vecchio collega, aveva notato subito il cadavere seminascosto.
“Certo, mi hanno ripreso,” rispose Billhardt. Sembrava che stesse riflettendo sull’opportunità di salutarlo più calorosamente. Alla fine gli porse la mano con un sorriso forzato. Non era difficile comprendere quell’esitazione. Poco più di due anni prima, in un momento di debolezza, aveva confessato all’ex collega che durante la guerra, in servizio sul fronte orientale, aveva ricevuto l’ordine di giustiziare dei civili, e aveva potuto sottrarsi a quella spirale di violenza solo perché una granata gli aveva portato via il braccio.
Oppenheimer sapeva che la polizia reintegrava gli ex dipendenti solo se non c’erano accuse a loro carico, perciò era abbastanza curioso di sapere come avesse fatto lui a nascondere il suo passato. Ma forse era stato sufficiente tacere quella macchia, nella speranza che i vertici avessero troppo da fare per controllare minuziosamente tutti i neoassunti. Di sicuro però Billhardt sapeva che Oppenheimer era al corrente della verità e che poteva rappresentare un pericolo per lui, se gli fosse venuto in mente di rivelare il coinvolgimento dell’ex collega in un crimine di guerra.
Per sciogliere la tensione, Oppenheimer tentò di alleggerire la conversazione con un’innocua domanda sulla moglie di Billhardt.
“Come sta Dorothee?”
“Ah, benissimo. Per fortuna i russi non l’hanno…” Ammutolì e lanciò un’occhiata ad Aksakov. Era meglio non accennare agli stupri in sua presenza. “Be’, hai capito. Comunque non le è successo niente. È rientrata dalla campagna solo dopo che Berlino era stata occupata. E Lisa?”
Per un istante Oppenheimer si sentì mozzare il fiato. Non aveva ancora superato del tutto l’idea che sua moglie non fosse stata altrettanto fortunata e aver arrestato il suo stupratore non cancellava ciò che le era successo. “Ah, Lisa lavora per i britannici a Charlottenburg,” si limitò perciò a rispondere. “Fa la traduttrice. Sai, prima insegnava inglese.”
Billhardt annuì cautamente. “Tu non lavori per la polizia, vero? Altrimenti l’avrei saputo di sicuro. Quelli cercano proprio persone come te, con diversi anni di esperienza e di provata integrità.”
“Al momento sono a posto,” ribatté Oppenheimer, volutamente ambiguo.
Come accadeva di frequente nei cortili nascosti di Berlino, anche in quello si aveva l’impressione di trovarsi in una stanza chiusa ermeticamente, sebbene pochi metri più in alto si potesse vedere il rettangolo del cielo. In un angolo c’era una tettoia per le bici, sopra la quale una scala di ferro conduceva fino al tetto. C’erano poche finestre, e la maggior parte della superficie era ricoperta da intonaco scrostato. Il lato più interno del cortile era completamente in rovina. L’ex commissario allungò il collo e riuscì a scorgere la strada al di là delle macerie.
“E il morto?” chiese Oppenheimer.
Quel commento fece ricordare a Billhardt dove si trovavano.
“È una strana faccenda,” disse scuotendo il capo. “E per rendere il tutto ancora più strano, non abbiamo il permesso di portare via il corpo perché deve venire non so quale specialista. Non ho idea di chi possa essere. La squadra per il rilevamento delle impronte è già arrivata, è tutto pronto, e invece no, dobbiamo starcene fermi ad aspettare e a girarci i pollici. Ma è una sciocchezza in confronto a tutti gli ostacoli con cui abbiamo a che fare. Sembra quasi uno scherzo, ma la centrale di polizia ha sede nel settore est, mentre il carcere giudiziario di Moabit e il giudice per le indagini preliminari sono entrambi nel settore britannico. Ti puoi immaginare il casino. Per ogni trasferimento di prigionieri i russi devono rilasciare un permesso, ma fanno sempre storie.”
L’accenno di Billhardt allo specialista che stavano attendendo aveva suscitato in lui un sospetto. “Forse il colonnello Aksakov ne sa qualcosa di più su questo specialista?” azzardò.
Per un istante Billhardt rimase in silenzio, poi si avvicinò agli altri uomini presenti. Erano due individui con identici cappelli grigi e un viso inespressivo e smunto come se ne vedevano tanti in giro per la città. Borbottarono qualcosa tra di loro, poi uno si voltò verso Aksakov e cominciò a parlare in un russo stentato.
“Lui è Wenzel,” spiegò Billhardt, senza presentarlo ufficialmente.
Il collega tradusse con voce sommessa la risposta di Aksakov, che scoppiò a ridere fragorosamente.
“Ma è ovvio,” sibilò indicando Oppenheimer. “Sei tu lo specialista. Non lo sapevi?”
“Non mi dice mai niente nessuno,” rispose l’ex commissario.
Lanciò un’occhiata interrogativa ad Aksakov, che si limitò ad annuire e poi indicò il cadavere.
“Davai! Davai!” ordinò a Oppenheimer, dopodiché si riavviò soddisfatto verso l’auto che lo attendeva.
Non appena Aksakov fu sparito, la tensione nel gruppo si sciolse. Adesso erano di nuovo soli, senza estranei a impicciarsi dei loro affari.
“Il colonnello vuole parlarle di nuovo domattina,” disse Wenzel. “Vuole un quadro della situazione.”
“Il compagno colonnello sembra tenerti in grande considerazione,” disse Billhardt facendogli l’occhiolino. “Come mai?”
“Ah, tempo fa ho risolto un caso per lui,” spiegò Oppenheimer laconico.
L’ex collega annuì con un gran sorriso. “E da allora il gatto non la smette di tormentare il topo, ho capito. Be’, vieni a guardare un po’ il nostro cliente. Stamattina, verso le nove meno un quarto, ci ha chiamati una residente dello stabile. Abbiamo mandato una pattuglia che ha trovato il cadavere.”
Nel corso della sua carriera di commissario della squadra omicidi, a Oppenheimer era capitato di vedere parecchi morti, ma quello spettacolo era così strano che non gli pareva di ricordare nessun caso analogo. Il morto giaceva in una posizione scomposta dietro i bidoni della spazzatura. Il riflesso della luce sulla sua pelle bianca quasi lo abbagliò, perché il corpo senza vita era inspiegabilmente nudo. L’ex commissario giudicò che fosse sulla settantina. Aveva le braccia spalancate e lo sguardo fisso rivolto al cielo. Gli fece venire in mente Icaro, che si era avvicinato troppo al sole ed era precipitato, perché il calore aveva fatto sciogliere la cera che teneva insieme le sue ali.
Le braccia e le gambe del morto erano coperte di scritte e la metà inferiore del viso era occupata dalla bocca spalancata. Oppenheimer si accovacciò accanto al cadavere per guardare meglio nell’apertura. Dietro la fila di denti, da cui ne mancava qualcuno, scoprì un pezzetto di carta carbonizzato.
“E quello cos’è?” chiese.
Billhardt si avvicinò, gli occhi puntati sul cadavere. “Probabilmente qualcuno gli ha infilato della carta in bocca e poi le ha dato fuoco. Quando la vicina l’ha scoperto bruciava ancora, lei si è presa un bello spavento. A parte qualche graffio, non si riscontrano particolari segni di violenza e nei paraggi non abbiamo trovato nessuna possibile arma del delitto. Quindi non possiamo escludere che la causa della morte sia naturale, anche se di sicuro questo signore non è venuto qui da solo a sdraiarsi nudo. E poi la carta carbonizzata in bocca… forse qualcuno voleva bruciare il corpo.”
Oppenheimer scosse la testa. “Bruciare un cadavere con qualche brandello di carta… no, non funziona. Servirebbe del combustibile.”
“Forse chi ci ha provato non poteva permettersi petrolio o alcol,” suggerì Billhardt.
Oppenheimer abbassò lo sguardo sui segni irregolari che coprivano gambe e braccia.
“Cosa sono questi? Tatuaggi? Possibile che fosse un marinaio?”
“Non sono tatuaggi,” disse Billhardt. “Quei segni sono stati tracciati sulla pelle con dell’inchiostro nero. A prima vista sembrano nomi.”